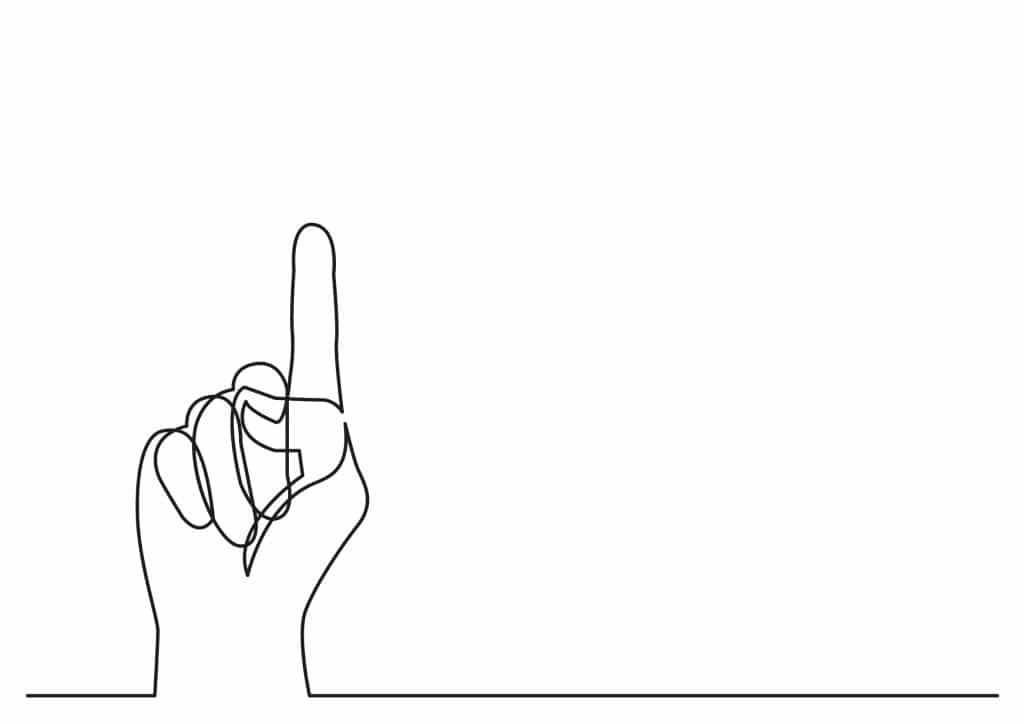Il rispetto dell’altro (e dell’opinione dell’altro) nella generalità della legge
Mai come in questo periodo, dove la crisi sanitaria fa da sfondo a nuovi modi di condotta e abitudini, ci siamo trovati a fare i conti con l’esigenza di un linguaggio giuridico chiaro, finanche univoco. Ognuno, nella propria esperienza quotidiana, si è trovato a confrontarsi coi diversi documenti normativi onde comprendere l’azione permessa, l’atto obbligato e quello vietato. A partire e al di là delle inedite difficoltà di questo periodo, chiarezza e certezza del diritto si appalesano quali necessità iscritte nella nostra quotidianità. Necessità, specularmente, che sono state erte a valori precipui della nostra cultura giuridica, a partire dall’Illuminismo e lungo il filo conduttore della codificazione napoleonica. Valori, quelli di chiarezza e certezza del diritto, che sono altresì rinvenibili quali sottesi ad altre espressioni del diritto, ivi compreso quello ebraico. Da Maimonide a Napoleone, per riprendere il perspicuo titolo di un articolo, reperibile in rete, di Julien Taieb (2007). Moti di codificazione, che siano del diritto laico o di quello ebraico, che mettono in evidenza i pericoli dell’ambiguità dei testi normativi e – a un livello più generale – il bisogno di limite, misura di cui il diritto si fa garante come, proprio in riferimento a Maimonide, ha sottolineato la filosofa Lucia Corso nel suo intervento per l’associazione LechLechà. Nondimeno, a partire da alcuni fenomeni che ricorrono nelle fonti ebraiche, è possibile porre in luce una differente, e non necessariamente antitetica, esperienza del diritto. Esperienza che pare porsi sul limite di quel linguaggio votato a definire e conchiudere in categorie universali e astratte, quali caratteristiche necessarie a rispondere al bisogno di certezza di cui sopra. Fenomeni ed esperienze liminari, potremmo notare, poiché posti nell’intercapedine tra due dimensioni o accezioni del linguaggio. La prima, del linguaggio che delimita il significato dei testi normativi e l’azione richiesta per legge, ponendo una soglia oltre la quale si “esce d’obbligo” (per riprendere un’espressione che ricorre anche nelle fonti della Tradizione). La seconda, del linguaggio che, pur essendo ancora iscritto nella dimensione giuridica, già quasi, per così dire, perturba i limiti della legge, segnalando forme di alterità, di eccedenza, vuoi sul piano del significato, vuoi su quello dell’azione concreta. Linguaggio che già scema oltre il giuridico, indicando potenzialmente in direzione della singolarità che eccede, in quanto tale, i contorni e il perimetro di ogni definizione.
Tale carattere ibrido, a metà strada tra la forma astratta e l’attenzione all’alterità, alla singolarità, è rintracciabile in fenomeni quali i Divre Ha-Iahid (parole del singolo), i Divre Le’batalà (parole ‘inutili’), ambedue menzionati in Mishnà Eduyot; nella Mahloquet LeShem Shammaim (la disputa, o divisione, in nome del Cielo, di cui si ha chiara enunciazione in Pirqé Avot), nel davar aher che ricorre tra commenti e halakhà (talvolta per rimandare, in assenza del nome proprio, all’opinione del Maestro di un’altra scuola). Ognuno di questi fenomeni sembra associarsi a una forma di dovere e di possibilità. Il dovere di conservare e ricordare le parole ‘del singolo’ o ‘inutili’, che in ambedue i casi non stabiliscono l’Halakhà; il dovere di “menzionare”, prima ancora della propria, l’opinione della Scuola avversa, come sancito da Beit Hillel in rapporto alle opinioni di Beth Shammai. Ancora, il dovere – ancorché in termini maggiormente sfumati, già prossimi alla mera possibilità – vuoi di citare la differente opinione di un altro Maestro in merito a un medesimo passo, vuoi la possibilità di pervenire a una differente spiegazione in merito a uno stesso passo o in rapporto a una stessa prescrizione. Così un filosofo del diritto, l’israeliano Hannina Ben Menachem, si è chiesto, in un’importante opera (2005), di cui è tra i curatori, quale fosse “lo statuto deontico”, e il corrispettivo giudizio valoriale, della Mahloket (della disputa, sottointeso di quella LeShem Shammaim, in nome del Cielo). Se, dunque, questa fosse giudicata dalla Tradizione positivamente, e in tal caso non solo permessa ma anche auspicata; o se invece fosse giudicata negativamente, quale esito della fine di un potere autoritativo centrale, e dunque sì tollerata ma anche, e al contempo, scoraggiata. E così via, lungo altre sfumature.
Secondo un approccio analogo si possono riscontrare, a partire dalle stesse spiegazioni fornite dalla Mishnà, due accezioni delle “parole del singolo” (Divre Ha-Iahid). Vuoi l’enunciazione di quell’opinione che non è da seguire, proprio perché formulata dal singolo (“da un tale”), esclusa in quanto minoritaria. Vuoi l’enunciazione di quell’opinione che, in determinate circostanze e poste determinate condizioni, potrà essere ripresa, così da poter permettere un differente orientamento di Halakhà a partire da un elemento interno alle fonti stesse. È ancora un filosofo israeliano, ben conosciuto all’estero, Moshe Halbertal, ad essersi occupato di tale aspetto. Rileva come le due tipologie di spiegazioni fornite rispetto alle parole del singolo (Divre Ha-iahid), nonché alcuni dei nodi toccati da Melamed in rapporto alla Mahlokhet (disputa, divisione), presentino degli elementi analoghi a quanto emerge in molta letteratura giusfilosofica in riferimento al fenomeno delle opinioni minoritarie enunciate da uno o più giudici in una data corte. E questo nonostante le ampie differenze storiche e giuridiche che distinguono i due generi di fenomeni. Analogie che paiono indicare un medesimo nodo dato dall’esistenza della pluralità – dei singoli e delle parti (dalla radice dell’etimo mahlokhet viene helek, parte, frazione) – in un contesto autoritativo e decisionale. Contesto dal quale ci si aspetterebbe, per le esigenze di certezza e univocità che si evocavano all’inizio, la sintesi, l’indicazione uniforme della linea d’azione da seguire e del significato di questa.
Un altro filosofo israeliano contemporaneo, Menachem Fisch, proveniente dall’ambito della filosofia della scienza, si è variamente occupato di alcuni dei fenomeni evocati. Nella raccolta The Rationality of Religious Dispute (2016), Fisch pone in evidenza come nel famoso passaggio per cui ‘queste e quelle [Beit Hillel e Shammai] sono parole del Dio vivente, e l’Halahà è secondo Beith Hillel’, non sarebbe tanto questione dell’adozione delle decisioni halakiche di Beith Hillel quanto, piuttosto, dell’adozione del modus operandi (meta-Hallakhà) di Beith Hillel. Dell’adozione, cioè, di determinati criteri di individuazione e formulazione di Halakhà. Criteri il cui cardine consisterebbe nel principio di modestia, e dunque nell’uso, proprio a Beith Hillel, a menzionare (ancor prima della propria) l’opinione dell’altra Scuola. Da qui Fisch si spinge oltre, indagando i possibili effetti culturali e politici di una modalità decisionale basata sul presupposto che l’altra parte, a sé avversa, abbia qualcosa di valido da dire. Effetti e implicazioni che secondo Fisch attengono non soltanto l’ebraismo di ieri, ma anche quello di oggi e che, segnatamente, interessano Israele quale società ebraica e plurale. Plurale sia perché contenente in sé diverse espressioni di ebraicità, sia perché comprensiva di minoranze non ebraiche.
Modestia di Beit Hillel, si potrebbe qui notare, di fronte al Nome, e al contempo modestia di fronte ai Maestri dell’altra scuola; possibile presupposto alla modestia verso l’altra opinione, in generale, e verso il singolo in quanto tale. A uno sguardo teoretico è proprio quest’ultimo passaggio che permette di riconoscere in tali fenomeni degli elementi interstiziali, al confine tra ciò che caratterizza il linguaggio giuridico quale linguaggio astratto e della delimitazione, e il linguaggio quale momento della non assimilazione, della non riduzione a uno, a identico. Forma di rispetto etico o, più radicalmente, etica della e attraverso la forma. Momento in cui la singolarità degli autori (nomi propri) delle diverse opinioni emerge quasi a perturbare la generalità della legge. Alla ricerca della de-limitazione legale si affianca così la tensione ermeneutica ridestata dall’opinione del ‘singolo’ (iahid), fosse anche tale opinione ‘inutile’ (…le’batalà) sul piano strettamente prescrittivo. Apertura di senso che sorge dal rapporto, di dipendenza e tensione, tra scrittura e lettura – della Scrittura come lettura, come David Banon indicava sulla scorta di uno dei sostantivi per Bibbia, Mikrà. Apertura che si riverbera nell’importanza conferita, nella forma e nel linguaggio giuridico, al singolo-altro. Qui il carattere interstiziale delle diverse forme di opinioni di minoranza, che paiono invitarci a due esperienze di tenore etico. A individuare nella forma linguistica il luogo della distanza, della differenza tra i singoli. Distanza da mantenere e rispettare. Da qui la seconda esperienza, fosse anche indiretta: quella del dovere verso il singolo in quanto tale, senza di cui non si darebbe parola. Dall’obbligo verso i Divre Ha-Iahid, parole del singolo, espresse in ambito giuridico, al dovere verso il singolo in quanto tale, Ha-Iahid, in rapporto – come suggerisce l’etimo in ebraico – a quell’unico – Ehad – che trascende le forme dell’immanenza. Santità (kedushà) dell’uno (ehad) esperita in virtù e a partire dalla distinzione del singolo (iahid): dalle sue parole alla sua mera presenza. Su questo sfondo il legame – come sovente ricordato – dal davar aher, altra opinione, all’ahariut (responsabilità). Nonché da altri sintagmi imparentati in ebraico alla medesima radice: mahar (domani), e ihur (ritardo). Rispettivamente, il nuovo, l’inedito, di cui garantendo la vita materiale dell’altro (in accordo all’adagio secondo cui salvando una vita salviamo un mondo) ci facciamo garanti. Il domani, come tempo in cui potrà aver luogo una differente interpretazione. Le opinioni minoritarie delle corti nel diritto statunitense sono state definite “voci profetiche”, in grado di preannunciare un futuro orientamento giurisprudenziale, come quando il giudice Harlan (Plessy v. Ferguson), solo, dissentì dal ritenere costituzionale la dottrina ‘separati ma uguali’. Il ritardo in cui, presi dalle ineludibili necessità della nostra quotidianità, necessità di sopravvivere e più estesamente di affermarci, ci possiamo scoprire verso l’altro.
Necessità di affermazione – di sicurezza e certezza – che ci riguardano come singoli e come collettività, e di cui il diritto sembra chiamato a farsi a un tempo garante e limite. Necessità che, proprio in quanto ineludibili, permettono di riconoscere il ritardo non in un lontano altrove – potere distante e a noi alieno – ma nel tempo presente e ordinario di ciascuno; tempo scandito dalle vicende concrete e attraversato dal diritto. L’esperienza delle opinioni del singolo e dell’altro attraverso il linguaggio giuridico potrebbe così, potenzialmente, segnalare come in qualche modo problematico il nostro muoverci all’interno dei limiti delle categorie astratte. La pur sottile consapevolezza di essere in ritardo verso l’altro può farsi così spinta ad andare oltre i limiti e la lettera della legge – lifnim mishurat a-din, per riprendere l’espressione delle fonti della Tradizione. Pure, quel limite, quella soglia, sono necessari. Come forme di delimitazione, segnando la distinzione tra etica e diritto. Compromesso, forse. Limite che rispondendo alle nostre quotidiane esigenze di certezza e sicurezza prepara la strada, in virtù della lettera stessa della legge, a poter scorgere ciò che a questa eccede.