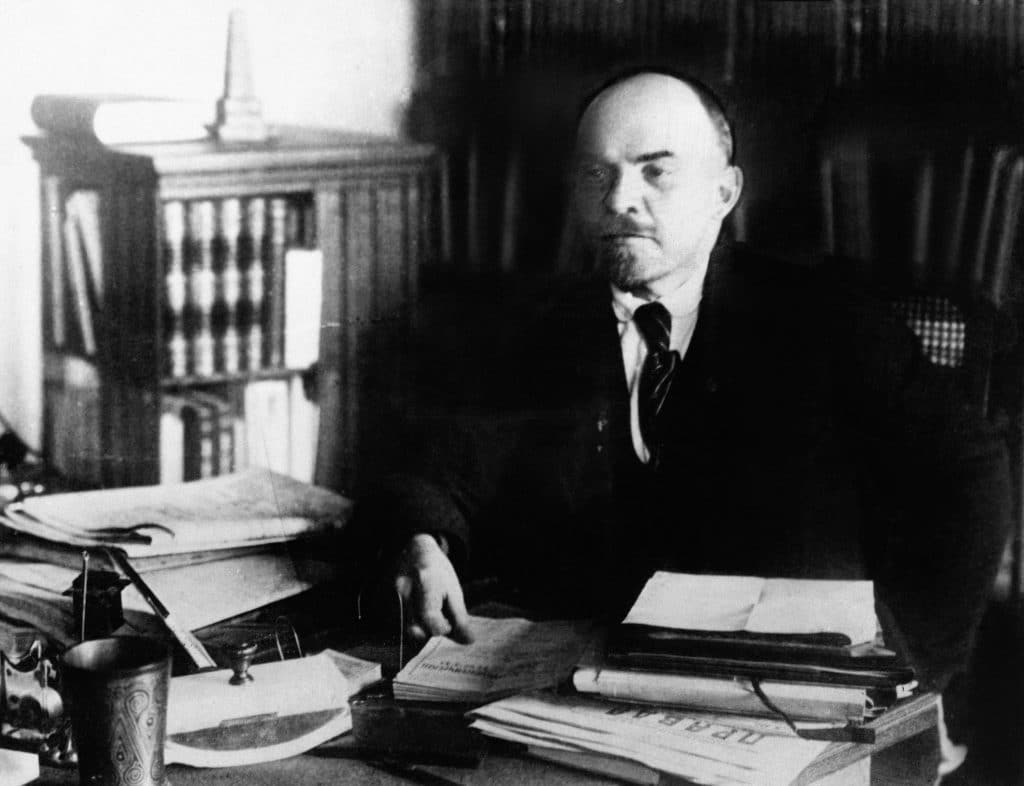
“Nella logica di Stalin, e con essa di Lenin, gli ebrei non costituivano una nazione e nemmeno un’aggregazione continuativa”. La seconda parte di un’approfondita analisi di Claudio Vercelli
Già si è avuto modo di dire, e ribadire, quale fosse il ruolo assegnato al proletariato e al sottoproletariato ebraico nell’Impero zarista: essere il capro espiatorio delle tantissime contraddizioni che accompagnavano il declino ineluttabile di un sistema di poteri e di interessi consegnati ad un crescente anacronismo. Le due rivoluzioni del 1917, quella di febbraio e poi quella di ottobre, si sarebbero incaricate di fare impietosa strame delle residue illusioni che allignavano ancora nei circoli di potere, nel mentre la società civile russa andava invece letteralmente spappolandosi. La Prima guerra mondiale, infatti, avrebbe segnato uno spartiacque definitivo. Il rapporto tra una parte cospicua dell’ebraismo russo – da distinguere, non solo per ragioni cronologiche ma anche politiche, culturali e sociali da quello sovietico, che sarebbe poi subentrato progressivamente negli anni Venti – e i movimenti rivoluzionari che attraversavano le lande dell’Est, va quindi inserito in questa dimensione di quadro. L’ebreo russo, operaio, artigiano o commerciante che fosse, era sfruttato quanto e più del mugicco (il contadino misero, vessato, privo di risorse, senza altro orizzonte che non fosse quello della sua stessa povertà) o del proletario industriale slavo. A ciò, si aggiungevano gli effetti devastanti delle politiche di Stato praticate dalle autorità e dalla Chiesa ortodossa, tanto più in questo caso due facce della stessa medaglia. Trono e altare erano il suggello inossidabile di una condizione segnata, per i più, dagli effetti devastanti di una crescente abiezione. Non solo di ordine materiale ma anche spirituale. Il divario tra una nobiltà ricca e parassitaria con il resto della società, si era fatto insuperabile. Tanto più dinanzi alla sordità della prima rispetto al crescente disagio della seconda. Peraltro, qualsiasi istanza politica che non fosse immediatamente compromessa con gli interessi dei circoli di potere, veniva bollata come sovversivismo e, quindi, sottoposta all’implacabile repressione della polizia politica.
L’ebraismo viveva quindi le sollecitazioni e le tensioni dell’epoca. Una parte della sua intellettualità, spesso ancora in rapporto di soggezione rispetto ai movimenti politici di matrice cristiana, nella seconda metà dell’Ottocento aderì al gruppo populista «Zemlya i Volya» («Terra e libertà»), destinato poi a confluire in «Narodnaya Volya» («Libertà del popolo»). Il transito era significativo poiché indicava il fatto che, sempre più spesso, si identificavano due uniche possibilità di emancipazione: la condivisione di un movimento rivoluzionario su “basi scientifiche” (di fatto un’illusione, destinata a confondere i processi sociali con quelli naturali, credendo che i primi potessero essere letti al pari dei secondi; tuttavia, finché resse alla prova degli eventi, una grande speranza distopica), per il quale più di una generazione si sacrificò generosamente, non meno che ingenuamente, laddove ebrei e non ebrei avrebbero comunque lottato accomunati; oppure la ricerca di una via autonoma, comunque basata sul “ritorno alla terra”, suggestione potentissima in quei decenni di transito tra un secolo e l’altro. Quest’ultima, infine ricondottasi – nel caso ebraico – al sionismo, vaticinava a sua volta la centralità del lavoro, soprattutto di quello rurale, nella rigenerazione etica e spirituale dell’uomo. In questo caso, dell’ebreo. Va aggiunto che – tuttavia – a lungo, tra i pensatori dell’emancipazione ebraica, il riferimento al «popolo» genericamente inteso (comprendendovi sia la componente ebraica che quella cristiana) ebbe la meglio rispetto a qualsiasi altro ordine di considerazioni. Non si trattava di una concessione ma, piuttosto, del rifiuto al ricorso alla matrice etnica che era invece usata dal potere russo per dividere e soggiogare le nazionalità imperiali. Un pensatore di primo piano come Paul Axelrod (1850-1929), attivista ed intellettuale rivoluzionario, pensava, come molti dei suoi pari, che alla liberazione di tutti (la collettività popolare, senza alcuna distinzione) avrebbe corrisposto quella di ognuno (ebreo e non che fosse).
Rimane il fatto che l’ebraismo, alla ricerca di un affrancamento sociale come anche in via di secolarizzazione, fosse vivamente partecipe dei convulsi moti clandestini a cavallo dei due secoli. Per rifarci alle statistiche dell’epoca, a fronte della significativa presenza di ebrei negli organismi direttivi di partiti, movimenti, gruppi e organizzazioni “rivoluzionarie” (spesso intimamente velleitarie, incapaci di mobilitare un largo consenso intorno a sé, caratterizzate da una sorta di ossessione teoretica, di eccesso di elaborazione intellettuale come anche da un concreto difetto di rapporto con la realtà sociale, il più delle volte fantasiosamente idealizzata), non era meno corposa la presenza, tra gli arrestati dalla polizia zarista, di «terroristi» (la dizione allora vigente) di membri delle comunità ebraiche. In genere, il rapporto statistico, al riguardo, era di uno a cinque; ovvero, ogni cinque oppositori, almeno uno era ebreo.
Le politiche dei governi zaristi in chiave antisemitica (proverbiale è la creazione nel 1903, da parte dell’Ochrana, la polizia segreta al servizio delle autorità russe, dei tristemente noti «Protocolli dei savi anziani di Sion», un falso documentale destinato tuttavia ad avere un successo universale) contribuirono comunque a segnare il passo anche tra quanti, invece, avrebbero invece dovuto condividere il medesimo cammino. In altre parole, mentre il movimento ispirato al «socialismo scientifico», di radice marxista, andava teorizzando l’inconsistenza delle appartenenze etniche per qualificare la vocazione rivoluzionaria (contando semmai l’ascrizione sociale, ossia di «classe», del tutto trasversale alle nazioni, alle religioni e ai gruppi etno-linguistici di origine), la grande famiglia del populismo russo, al contrario, la recuperava integralmente. Per l’ebraismo, un tale passaggio costituì un tornante pieno di conseguenze. Poiché lo riconsegnava alle sue premesse, facendo “giustizia” delle ipotesi assimilazioniste, a questo punto del tutto illusorie e, quindi, obbligandolo a ripensare, nelle sue stesse premesse, alla radice dell’azione politica nella quale intendeva continuare ad identificarsi. Poche parole per dire che i populisti, allora ampiamente diffusi nella società russa, preservavano molte delle venature antiebraiche contro le quali, invece, qualsiasi movimento di rinnovamento sociale si sarebbe dovuto esprimere in maniera inequivocabile. Non per bontà morale bensì per necessità politica comune.
Rimane il fatto che in questo nuovo orizzonte ebraico, poco o nulla veniva concesso ad una sorta di separazionismo comunitario (quello che invece, alcuni decenni dopo, la destra ebraica di matrice nazionalista, avrebbe praticato; qualcosa del tipo: “solo tra di noi, uniti contro il resto del mondo, altrimenti composto di esclusivi antisemiti”) mentre si continuava a predicare l’«azione di massa», ossia la partecipazione agli scioperi, la presenza in tutte le occasioni e le circostanze di mobilitazione, non distinguendo tra ebrei e non ebrei. Il vero anello di congiunzione tra una ritrovata identità ebraica, declinata in chiave di autocoscienza, e il resto dell’umanità, ero lo yiddish. Non solo lingua vernacolare ma vero e proprio vettore di un’identità proletarizzante. L’ampia diffusione di periodici come «Yiddish Arbeiter» (il «lavoratore yiddish») e «Arbeiter Achtimme» ne erano il suggello. Lo yiddish identificava i caratteri culturali di una società ebraica che nel rapporto tra lavoro, coscienza politica e azione consapevole riteneva di potere concorrere alla propria e all’altrui rigenerazione. Aspetti di questa consapevolezza, vissuta come identità ma non come estraneità al resto del mondo, sarebbero giunti fino alla strenua lotta del partigianato ebraico nell’Europa orientale durante l’occupazione nazista tra il 1941 e il 1944.
La vicenda della nascita e dello sviluppo del Bund (l’«Unione generale dei lavoratori ebrei della Lituania, Polonia e Russia») tra il 1897 e il 1943, ne fu infatti la definitiva testimonianza. Non è questo il luogo per ritornarci sopra. Rimane il fatto che la militanza in un partito territorialista ma non sionista costituisca il più originale contributo ebraico allo sviluppo del socialismo in Europa. In altre parole: sì al radicamento nelle terre di origine; rifiuto, invece, di un’ipotesi nazionale per la soluzione dei veri problemi degli ebrei, dall’antisemitismo all’assimilazionismo, nel nome semmai dell’«internazionalismo», ossia l’universalità del disagio dei lavoratori al quale si può dare un’unica risposta, collettiva, egalitaria, al medesimo tempo politica e morale, che coinvolga chiunque sia sfruttato, La durissima polemica che, dalla fine dell’Ottocento in poi avrebbe preso piede tra bundisti e sionisti, ha senz’altro molto della feroce divisione dottrinaria che accompagnava i movimenti politici dell’epoca ma, non di meno, ritraduce, nel linguaggio politico ebraico, le profonde tensioni che stavano accompagnando intere collettività verso orizzonti di partecipazione alla politica di massa.
Il Bund avanzava al socialismo russo, che andava strutturandosi come soggetto decisivo nella contesa politica che si accompagnava al progressivo sfacelo della società imperiale, alcune specifiche richieste. Fermo restando che il Partito operaio socialdemocratico russo (il Posdr), nato nel 1898, un anno dopo il Bund, vide la partecipazione di un grande numero di ebrei tra i suoi dirigenti (di fatto, tra i più importanti, in un primo tempo, solo Lenin non lo era; gli altri invece sì, come nel caso di Plekhanov, Axelrod, Martov e poi Bronstein, quest’ultimo meglio conosciuto come Trotzki), per i bundisti (che entrarono nelle file dei socialdemocratici lo stesso anno di fondazione della socialdemocrazia rivoluzionaria, pur rivendicando la loro natura di «organizzazione autonoma, indipendente solo per le questioni attinenti la specificità del proletariato ebraico») era semmai fondamentale trasformare la Russia in una federazione di nazionalità. In tale ottica, si opponevano al nazionalismo sionista, inteso invece come una sorta di «deviazione borghese» rispetto ad una prospettiva autenticamente rivoluzionaria. Una tale posizione, basata sull’autonomia nazionale ebraica, si sarebbe però presto rivelata perdente, soprattutto all’interno della socialdemocrazia russa, dove invece avanzava l’idea che nessuna matrice soggettiva potesse avere reale spazio, optando semmai per un unico obiettivo, quello di un partito rivoluzionario, di élite, fortemente centralizzato, sostanzialmente estraneo alle eventuali rivendicazioni particolariste. Ai dirigenti socialdemocratici era chiaro che, lasciando spazio alle istanze ebraiche, sarebbero seguite le rivendicazioni di autonomia (e quindi di indipendenza) di polacchi, lituani, lettoni, georgiani, ucraini e così via. La nuova Russia, per quella che dal 1903 sarebbe stata la fazione vincente dentro la socialdemocrazia, i bolscevichi di Lenin, doveva senz’altro essere un organismo collettivista ma fondato sull’unitarietà delle diverse nazionalità. In altre parole, le minoranze oppresse dovevano essere liberate dal giogo che le imprigionava ma il principio della continuità della sovranità, destinato ad essere ereditato dal declinate impero zarista, non poteva certo essere messo in discussione.
L’intera questione politica si era quindi trasposta in un lungo dibattito, a tratti quasi ossessivo, sull’esistenza o meno delle identità nazionali, sui loro eventuali caratteri distintivi e su come socialismo (e poi, in immediata successione, il comunismo) avrebbero posto rimedio ai differenziali di diritti, opportunità e poteri tra di esse. La canonica posizione assunta da Lenin, e quindi ripetuta come un verbo incontrovertibile, era che l’emancipazione sociale ed economica, insieme all’egualitarismo, avrebbero fatto giustizia dei tanti problemi preesistenti, portando ad una sorta di assimilazione di fatto tra comunità differenti. L’armonia sarebbe quindi subentrata, in quanto ovvia evoluzione della “natura” delle relazioni umane. La rilevanza dei caratteri culturali era pressoché azzerata. La specificità religiosa (come tratto di identità comunitaria), va da sé che neanche fosse presa in minima considerazione. Riecheggiava l’idea che in fondo si trattasse di una questione di residue superstizioni. Trascurando così del tutto un elemento invece rilevante nel modo di porsi dei gruppi sociali e culturali rispetto al mondo, e ai suoi cambiamenti. In realtà, le linee di divisione ideologica contavano, all’epoca, assai meno della concreta propensione all’azione politica. Se il Bund era uscito dalla socialdemocrazia nel 1903, tre anni dopo vi era invece rientrato. Sia pure con molti distinguo, in un percorso che sarebbe stato sempre e comunque accidentato. I temi di dottrina erano parte di un dibattito acceso ma per nulla decisivo. Già allora si sapeva che, a conti fatti, avrebbe contato la capacità di volgere pragmaticamente a proprio favore lo sviluppo dei fatti. Ci sarebbero voluti dieci anni circa, e nel mentre una guerra mondiale, ma la traiettoria dei fatti si sarebbe incaricata di dare ragione alla perseveranza dei “rivoluzionari”.
Nel 1907, per dare il polso della situazione, al congresso del Posdr tenutosi in esilio a Londra (farlo in Russia avrebbe comportato l’immediato arresto di tutti i partecipanti), dei 258 delegati almeno un quinto era bundista ed un quarto bolscevico. Tra questi ultimi – corrispondenti complessivamente a circa un centinaio – una dozzina erano ebrei mentre nella “minoranza” menscevica lo erano ben ventidue. A conti fatti, la socialdemocrazia rivoluzionaria russa contava, tra i suoi esponenti di maggiore spicco, almeno un terzo di ebrei. Iosif Vissarionovič Džugašvili, ovveroStalin, all’epoca già presente sulle scene politiche, non a caso riscontrava, in un articolo di quell’anno, redatto in tempi immediatamente successivi al congresso, che «la maggioranza della frazione menscevica è costituita dagli ebrei […] mentre i russi costituiscono la stragrande maggioranza della frazione bolscevica». A questa elementare statistica aggiungeva la considerazione per cui «non è difficile spiegare questa composizione delle frazioni: il bolscevismo trova seguito principalmente nelle aree della grande industria, regioni abitate, ad esclusione della Polonia, da autentici russi, mentre il menscevismo attecchisce nelle zone della piccola industria che sono abitate prevalentemente da ebrei […]».
Dopo la rivoluzione del 1905, ovvero a seguito della sconfitta russa nella guerra contro il Giappone, con la conseguente nascita del primo parlamento (la Duma) e dei Soviet (i consigli rivoluzionari degli operai e dei contadini), nel pieno di un’ottusa repressione zarista – che infuriò per circa sei anni, tra il 1908 e il 1914 – causando innumerevoli lutti, la posizione socialdemocratica rivoluzionaria verso le «nazionalità» mutò ancora, assumendo formalmente la legittimità del diritto alla loro autodeterminazione e, in prospettiva, all’eventuale indipendenza politica. Peraltro lo stesso Stalin, su evidente influenza di Lenin, nel 1913 si incaricava di redigere e quindi pubblicare un saggio su «il marxismo e la questione nazionale» nel quale, a fronte del fragile riconoscimento dell’esistenza di ciò che erano per l’appunto definite come nazionalità (per l’autore: «una comunanza stabile, storicamente determinata, di linguaggio, di territorio, di vita economica, di costituzione psicologica, che trova espressione in una comunanza di cultura») si rifiutava invece la disposizione della socialdemocrazia rivoluzionaria nei confronti di qualsiasi richiesta di separazione dalla Russia. La cui unitarietà, ancora una volta, si ribadiva che dovesse essere tutelata a prescindere da ogni altro ordine di considerazioni. L’eventuale indipendenza nazionale, singolarmente valutata, di volta in volta, poteva essere accettata qualora soddisfacesse gli “interessi del proletariato internazionale”. L’intero saggio di Stalin era peraltro una perorazione contro l’«ondata di nazionalismo», intesa come una sorta di afflizione che avrebbe potuto distruggere le prospettive di una rivoluzione mondiale. La cosiddetta nazione, in buona sostanza, non esisteva se non nella misura in cui essa fosse funzionale a definire gli interessi delle classi lavoratrici, di contro a quelli della borghesia.
Nella logica di Stalin – e con essa di Lenin – gli ebrei non costituivano una nazione. Non almeno un’aggregazione continuativa, caratterizzata dagli elementi che, invece, potevano essere attribuiti ad altri gruppi. Già lo stesso Lenin, nello stesso 1913, riferendosi, con un complesso articolo dedicato a «note critiche alla questione nazionale», dinanzi alla concretezza dell’insediamento ebraico in Lituania, Polonia, Ucraina e Bielorussia parlava semmai di «casta». La qual cosa, nel linguaggio pseudo-antropologico dell’autore, rimandava ad un gruppo sociale senz’altro omogeneo, composto da individui che si vivevano come “diversi” e quindi separati dal resto dell’ambiente circostante, ma privo di caratteri culturali tali da farne una nazionalità a sé. In essi, semmai, predominava la condizione di subalternità socioeconomica il cui superamento poteva essere garantito solo dalla più completa integrazione e, a seguire, dall’assimilazione con il resto della popolazione. Perché, sembravano chiedersi Lenin e Stalin, auspicare il prosieguo di una fittizia appartenenza ebraica quando, invece, il vero problema era la lotta all’antisemitismo in quanto strumento delle classi dominanti (la borghesia) contro quelle subalterne (il proletariato), laddove si dirottava la loro esasperazione contro un capro espiatorio, ovvero gli ebrei medesimi? Il giorno in cui tutte le discriminazioni fossero state abolite, le ingiustizie cancellate o comunque combattute, le distinzioni fittizie abrogate, l’ebraismo avrebbe superato se stesso, di fatto riconoscendosi nel flusso della storia, quello dettato dall’evoluzione “naturale” della società finalmente liberata dalle nequizie di un sistema sociale basato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Del quale, il discorso sulla «nazione», in quanto autoinganno, serviva essenzialmente a mantenere e a riprodurre ideologicamente le diseguaglianze e i divari che erano alla base dell’infelicità umana.
(2 – continua)
Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.
