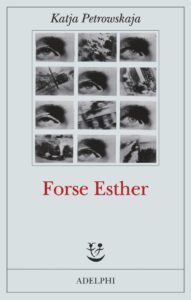Uno splendido romanzo che mette in forse ogni certezza, ogni credenza e ogni assolutismo. A cominciare dallo stile narrativo. Un invito alla lettura del volume uscito in Italia nel 2014.
Una molletta da capelli, la leggenda di un ficus salvatore, alcune fotografie in bianco e nero, una ricetta ebraica orientale con insalata, aglio e finocchio selvatico. Sono alcuni dei frammenti raccolti da Katja Petrowskaja nella sua opera prima Forse Esther, pluripremiata in molti paesi e anche in Italia, dove ha vinto il Premio Strega per romanzi stranieri immediatamente dopo la pubblicazione nel 2014. La scrittrice compone un mosaico della storia d’Europa attraverso l’indagine sui diversi rami della propria famiglia, una famiglia ebraica dispersa tra Otto e Novecento in imperi che esistono oggi solo sulle pagine dei libri di storia o sulle antiche mappe, da quello austroungarico a quello dello zar fino a quello sovietico. La ricostruzione di cui Forse Esther è il risultato non è per nulla lineare, non muove sotto gli auspici di granitiche sicurezze ma si fa forte della stessa oscurità che pure scalfisce, gettando luce su un gigantesco passato dimenticato grazie a brandelli di storie, un pugno di parole, nomi, qualche documento e qualche immagine.
Si tratta tuttavia di luce fioca e parziale, del tutto insufficiente alla ricostruzione dei fatti così come si sono svolti. Petrowskaja si muove a tentoni in un multiverso per nulla ordinato pieno di rumore, in cui è difficile trovare le informazioni rilevanti in mezzo al bombardamento incessante dei dati. Google, che “regna su di noi come il Padreterno”, presenta uno stuolo di opportunità e rischi inediti; il suo utilizzo interseca una pletora di voci, memorie, gesti, figure che non vengono pietrificate in una ingenua redazione definitiva della storia, come se una versione di questo tipo fosse possibile, ma fluttuano nel mare vastissimo e sempre aperto delle possibilità dove il principio di non contraddizione non è sovrano. La scrittura è in grado di salvare qualcosa e vincere l’oblio traendo a sé elementi dal passato nebuloso: non verità inconcusse, però, e neppure sempre gli elementi più importanti; al contrario salva e conserva storie selezionate a casaccio dalla memoria, storie il cui valore è tale non perché rappresentano assolute certezze, rocce cui aggrapparsi nell’oceano della dimenticanza, ma plausibili alternative immobilizzate dai caratteri neri che procedono dalla penna, o meglio dalla tastiera di un pc.
La ricchezza e l’attualità più grandi di Forse Esther stanno proprio qui. Forse stanno qui, dovremmo dire, perché è quello dell’ipotesi il mondo del libro e forse – ancora forse – di tutti i libri onesti che non nascono dalla presunzione di esporre la versione ufficiale e completa e intangibile su qualcuno o qualcosa. In quasi ogni pagina affiora il desiderio dell’autrice di andare alla ricerca delle proprie radici non per guadagnare certezze, come abbiamo visto, ma per sfidare l’abisso dell’oblio, non per avvicinare a sé gli antenati scomparsi appropriandosi delle loro storie ma per avvicinarsi loro con discrezione e affetto. In questa caccia alla memoria perduta di un collettivo di zii e prozii e nonne e bisnonne le madeleines da inzuppare nel tè sono gli oggetti e i racconti, alla cui rievocazione si intrecciano fotografie, come in Winfried G. Sebald, e un periodare lungo rotto da incisi e considerazioni personali, come in Thomas Bernhardt, a cui si accompagnano parentesi introspettive e di invenzione. L’autrice documenta frammenti della vita quotidiana degli avi come L’uomo con la macchina da presa, il film di Dziga Vertov (Boris Kaufman) i cui fotogrammi sono riprodotti sulla copertina dell’edizione Adelphi, documenta la corsa verso la modernità e il progresso nella neonata Unione Sovietica.
Katja Petrowskaja, nata a Kiev nel 1970, è cresciuta in un paese che imponeva la cancellazione delle particolarità e delle appartenenze, a partire da quelle famigliari, e propagandava questa distruzione come apertura dei cancelli sul futuro. Non esisteva storia fuori da quella anonima dello stato, cioè del partito e della sua nomenklatura. “Noi eravamo bambini sovietici, tutti uguali, con storie di famiglia immerse nella stessa nebbia, quella nebbia che, forse, costituiva proprio il presupposto della nostra uguaglianza”. Il regime rovina all’inizio degli anni novanta, Katja come molti altri “ebrei per caso” sovietici va a vivere a Berlino e poco alla volta scopre vicende dimenticate della sua famiglia e il racconto si popola di volti e di luoghi, tutti ammantati di incertezza. Il padre le raccontava di una bisnonna il cui nome forse era Esther e forse no, lui non era sicuro perché quando era piccolo i figli la chiamavano mamma e i nipoti babuška, e di come questa figura fragile senza neanche un nome certo si fosse incamminata il 29 settembre 1941 con tutti gli altri ebrei di Kiev verso la forra di Babij Jar, avesse forse chiesto informazioni sulla strada da seguire a un soldato tedesco e in risposta fosse stata distrattamente assassinata con un colpo di pistola sul marciapiede. Emerge la figura di un’altra nonna, Rosa, che insegnava a parlare ai bambini sordomuti come molti dei suoi avi tra Vienna e Varsavia e Kiev, tutti logopedisti e fondatori di orfanotrofi e insegnanti, e babuška Rosa nel 1941 aveva lasciato Kiev poco prima dell’arrivo dei tedeschi, cioè della morte, su un carretto insieme alle due figlie, tra cui la madre della scrittrice. C’è poi un nonno non ebreo catturato dai tedeschi durante l’operazione Barbarossa e deportato a Mauthausen, poi dopo la guerra sopravvissuto anche ai “nostri lager”, cioè i gulag, ai quali era stato destinato perché colpevole di essere sopravvissuto a quattro anni di prigionia in Germania e in Austria mentre quasi tutti i suoi compagni erano morti, e c’è l’attesa paziente della nonna che dura quarant’anni. C’è il prozio Judas Stern che nel 1932 aveva sparato contro un diplomatico tedesco, era stato processato e non se ne era saputo più nulla, era certo entrato “nel mondo della materia disorganizzata”, come si diceva alludendo a Lubjanka e dintorni. C’è un bisnonno che aveva cambiato cognome in onore della rivoluzione, e poi Stern suonava davvero troppo ebraico. C’è la storia del ficus abbandonato a bordo strada per fare posto al padre di Katja sul carro in fuga da Kiev, e allora la rinuncia alla pianta significa la vita del padre bambino, e però lui da adulto non ricordava nessun ficus…
Quasi altrettanto importanti, ecco i luoghi: il casermone di cemento a Kiev in ulica Florencii, cioè strada Firenze, la Polonia perduta, Mauthausen, la Berlino di oggi, quasi fanaticamente contro la guerra al punto da dare per scontato che Bombardier sia un musical francese e non la minaccia di radere al suolo la città, e allora Bombardier Wilkommen in Berlin. E poi Babij Jar, abisso nero, dopo la quale non esistono più ebrei a Kiev, il 28 settembre in città vivevano ancora 34.000 ebrei e la sera del 30 nessuno, tutti nella forra tranne babuška Esther, abbandonata sul marciapiede. E c’è la storia della memoria di Babij Jar, ma dovremmo dire la storia della negazione della memoria, perché nell’Unione Sovietica di Stalin e dei suoi successori non c’era posto per la Shoah e allora gli ebrei di Kiev non erano morti, non erano neanche nati a ben vedere, semplicemente non erano, tutti i popoli sovietici avevano patito nella stessa misura l’invasione tedesca e partecipato alla grande guerra patriottica.
Katja Petrowskaja viaggia attraverso l’Europa spezzata da nuove frontiere che intersecano vecchie cicatrici ancora ben visibili e raccoglie un coro di voci di personaggi remoti. Il suo è un racconto europeo in una lingua europea, la stessa lingua del praghese Kafka e di Canetti, nato a Rustschuk (oggi Ruse) in Bulgaria da genitori sefarditi; la lingua della civiltà danubiana, koinè largamente ebraica; la lingua che offre la base allo yiddish; ma anche la lingua del nemico, quella degli assassini. Il tedesco insomma, lingua amata perduta temuta anche comprensibilmente odiata, è la bacchetta da rabdomante dell’autrice che a trent’anni va a vivere a Berlino e impara il tedesco e vive e scrive in tedesco. “Pensavo in russo, cercavo i miei parenti yiddish e scrivevo in tedesco. Avevo la fortuna di potermi muovere nelle crepe della lingua, nello scambio e nella variazione continua dei ruoli e dei punti di vista”. Siamo abituati a pensare che una lingua sia luogo sicuro dove ci si sente a casa, adesso sappiamo che è anche strumento per non sentirsi a casa, e non è cosa meno importante. Da qui, dalla lingua di Heine e di Auschwitz, di Josef Roth e Wittgenstein comincia la raccolta dei frammenti, qui comincia e continua la storia d’Europa. Forse.
Katja Petrowskaja, Forse Esther, traduzione di Ada Vigliani, pp.241, 18 euro, Adelphi