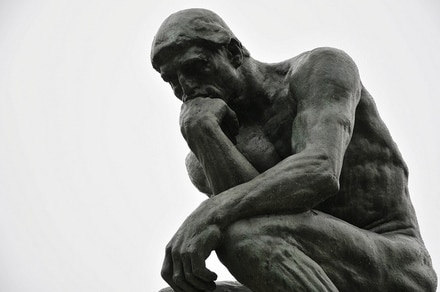
L’irrinunciabile – umana – attrazione per la trascendenza
Quando si parla di ascesi, abnegazione e automortificazione, l’immagine che balza immediatamente alla mente può essere quella di un anacoreta indiano talmente consunto dal digiuno da poter tastare le ossa della colonna dorsale toccandosi la pancia, come descritto da Hermann Hesse in Siddharta, o quella di un eremita cristiano, sudicio ma ieratico, assiso in cima a una colonna, come ben ritratto dallo stilita Colombino di Brancaleone alle crociate. Siamo infatti abituati a pensare che l’ascetismo sia una prerogativa, pratica e spirituale, di alcune religioni, come il buddhismo e il cristianesimo, alla quale si contrappone lo spirito gioioso e vitale di altre, come il giudaismo. Ciò è vero solo in parte, perché la cultura ebraica è stata ed è sufficientemente poliedrica da incorporare al suo interno anche fenomeni ascetici.
Verso la trascendenza
Ma un passo per volta. Che cos’è l’ascetismo? Per una definizione classica, prendiamo l’Encyclopedia of Religion diretta da Mircea Eliade, dove troviamo il nostro concetto definito come “un programma volontario, sostenuto e almeno parzialmente sistematico di autodisciplina e abnegazione per il quale si rinuncia alle gratificazioni immediate, sensuali o profane così da raggiungere un più alto stato spirituale o una più profonda discesa nella sacertà. Poiché l’uomo […] ricerca lo stato trascendentale, l’ascetismo […] è virtualmente universale in tutte le religioni”. Se tutte le religioni sono potenzialmente ascetiche, è anche facile capire perché si tenda a ritenere alcune religioni più ascetiche di altre, parafrasando George Orwell. Ma veniamo piuttosto a esplorare come l’ebraismo abbia interpretato la scelta di privarsi del piacere terreno al fine di approssimarsi al divino. Prevedibilmente, il viaggio non può non cominciare dalla Bibbia – e più precisamente da Numeri 6,1-21 e Giudici 13,1-14, dove si legifera sull’istituto del nazireato. Il nazir, ovvero il separato, è chi – uomo o donna – prende l’impegno di consacrarsi a YHWH per un periodo di tempo durante il quale si asterrà dal consumare i prodotti della vigna, dal tagliarsi i capelli, dal venire a contatto con l’impurità della morte. Il concetto chiave per capire questo costume è quello di sacertà: sacro è ciò che si separa dal profano per partecipare della trascendenza divina. Qedushà (sacertà) e perishut (separazione) saranno infatti i concetti attorno a cui ruoterà l’ascesi ebraica.
Un esempio più tardo di come il sacro richieda speciale rigore comportamentale è la celebrazione del sabato come trasmessa dal libro apocrifo dei Giubilei (50,8, I-II sec. a.e.v.): “Lavorerai per sei giorni e il settimo giorno è il sabato del Signore. […] E colui che in esso fa qualche lavoro, muoia! E chiunque lo profani, chi si corica con la moglie […], muoia!”. Nella cultura ebraica all’epoca del Secondo Tempio, il sesso stava diventando (come diverrà evidente qualche secolo dopo con il cristianesimo) fonte di impurità non solo fisica ma anche morale, cosicché preservare la sacralità di un dato momento significava astenersi dall’impudicizia. Altre fonti di epoca non lontana (I-II sec. e.v.) testimoniano invece come per poter mettersi in contatto diretto con la divinità sia necessario, per un profeta o aspirante tale, adottare alcuni accorgimenti come allontanarsi dalla città, digiunare per svariati giorni per poi nutrirsi di “erba del campo”: è così che Ezra e Baruc, nelle rispettive Apocalissi, riceveranno rivelazioni profetiche sul destino terreno e ultraterreno di Gerusalemme.
La via mediana
Ma caduto il Tempio gerosolimitano, e di conseguenza terminata l’epoca della rivelazione e del culto sacrificale, cosa resta dell’ascetismo nella religione ebraica, in fase di riassestamento e ridefinizione nel corso della tarda antichità? La letteratura rabbinica, com’è intrinseco alla sua natura, registra voci differenti: nei Pirqe Avot, i Detti dei padri, abbiamo opinioni contrastanti sulla questione se sia giusto o meno abbandonare la vita secolare per dedicarsi anima e corpo allo studio della Torà. Anche il trattato Yevamot (Cognate 8,7) della raccolta legale dal titolo Tosefta (II sec. e.v.) affronta il problema nei seguenti termini:
Rabbi Eleazar ben Azaria diceva: Chi non espleta il precetto di “siate fecondi e moltiplicatevi”, è come se commettesse omicidio e cancellasse l’immagine divina, che è scritto “a immagine divina fece l’uomo” (Genesi 9,6) e “siate fecondi e moltiplicatevi” (Genesi 9,7). Ben Azzai ripeteva lo stesso insegnamento. Allora Rabbi Eleazar ben Azaria gli disse: “Ben Azzai, le parole sono belle quando escono dalla bocca di chi le mette in pratica. C’è chi predica bene e razzola male, e chi predica male e razzola bene. Ben Azzai è di quelli che predicano bene e razzolano male.” Gli rispose Ben Azzai: “Che posso farci? È la Torà che io desidero, lascia che siano gli altri a far andare avanti il mondo”.
La contraddizione tra la mitzwà sulla perpetuazione della specie e la scelta di astensione sessuale viene risolta in favore di una mezza misura, un millennio dopo, dal rabbi catalano Nahmanide (1194-1270). Nel commento a Levitico 19,2 (“Parla con la comunità degli israeliti e di’ loro: Siate sacri, perché io, il Signore Iddio vostro, sono sacro”), Nahmanide propone:
“Siate sacri – siate separati dal peccato sessuale e dalla trasgressione in genere. […] Per come la vedo io, la separazione riguarda coloro che si definiscono “astinenti (separati, perushim)”. La questione è che la Torà mette in guardia dal peccato sessuale e dai cibi proibiti, ma permette sia che un uomo abbia rapporti con sua moglie sia il consumo di carne e vino. In questo modo, succede che chi è preda dei propri appetiti trova spazio per indulgere nella lussuria con sua moglie o con le sue molte donne, o per diventare uno “dei ghiottoni di vino, dei divoratori di carne” (Proverbi 23,20). Perciò è scritto […] di astenersi dai cibi permessi e minimizzare il coito, come è stato detto (in Berakhot 22a) che i discepoli dei sapienti non devono accostarsi alle loro donne come galli né devono avere rapporti se non nella misura in cui si compie il relativo precetto.
Il pentimento
Assieme all’ambivalenza del piacere sessuale, un altro tema centrale per comprendere l’ascetismo ebraico è il concetto di teshuvà, ossia di pentimento, letteralmente di ritorno a Dio e dunque allo stato di integrità precedente al peccato. Nella qabbalà questo principio rappresenta una, se non la prima, delle vie attraverso cui raggiungere la shelemut, la perfezione spirituale. Una delle testimonianze più note e abusate per mettere in risalto la tendenza ascetica della cosiddetta qabbalà lurianica – ovvero della cultura mistica sviluppatasi a Safed, in Palestina, dal XVI secolo – è tratta dalle Toledot ha-Ari, la Storia di Isaac Luria, il fondatore del movimento (XVII secolo):
Inoltre, questo sant’uomo (hasid, il cabbalista Avraham ben Eliezer ha-Levi Berukim [1515-1593]) praticava un altro costume – ovvero andava per piazze e vie chiamando al pentimento. Riuniva una frotta di penitenti presso la sinagoga dei Babilonesi, e lì diceva loro: “Guardate ciò che faccio, e fatelo anche voi”. Si infilava in un sacco e ordinava di trascinarlo per tutta la sinagoga, così da umiliarlo e sottomettere il suo yezter (istinto). Poi ordinava di prenderlo a sassate. E quelle pietre pesavano una libbra e mezza. E con quelle pietre lo lapidavano. Poi si liberava del sacco e si faceva preparare un letto di ortiche che urticavano la carne come fuoco, quelle che chiamano “Brennesseln”. Si levava i vestiti e si gettava nudo tra le ortiche, rigirandosi tra esse finché non gli si ricopriva il corpo di pustole. […] Dopo di che diceva agli astanti: “Miei rabbi, chi di voi desideri scampare al giudizio della Geenna faccia ciò che io ho fatto”. E subito quelli si precipitarono tutti insieme a farsi carico dei medesimi tormenti, piangendo amaramente e confessando i propri peccati, senza muoversi di lì finché non fossero stati perfetti nella penitenza ogni giorno della loro vita.
L’attendibilità storica sulla diffusione di queste pratiche presso i cabalisti di Safed è oggetto di dibattito accademico. Sicuramente l’immagine dei penitenti luriani come cugini entusiasti dei flagellanti à la Bergman è estrema. Inoltre non va dimenticato che il percorso ascetico di auto-perfezionamento spirituale non riguardava tutti gli strati della popolazione ebraica ma era appannaggio di pochi felici. Felici, separati e sacri.
Ilaria Briata è dottore di ricerca in Lingua e cultura ebraica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha pubblicato con Paideia Editrice Due trattati rabbinici di galateo. Derek Eres Rabbah e Derek Eres Zuta. Ha collaborato con il progetto E.S.THE.R dell’Università di Verona sul teatro degli ebrei sefarditi in Italia. Clericus vagans, non smette di setacciare l’Europa e il Mediterraneo alla ricerca di cose bizzarre e dimenticate, ebraiche e non, ma soprattutto ebraiche.
