
Riflessioni su Betzà, il trattato talmudico appena tradotto in italiano
Betzà, in ebraico, significa uovo. Con questo nome è conosciuto il trattato del Talmud babilonese dedicato a ciò che è permesso e a ciò che è proibito fare nei giorni festivi (Yom Tov) rispetto alle nome che regolano lo Shabbat. In particolare e in concreto, cosa significhi che nei giorni festivi è permesso “preparare il cibo necessario ad ognuno” secondo quel che dice la Torà (cfr. Shemot/Es 12,16). Sembra una questione facile, ma chi si metta a leggere – anzi, a studiare – questo trattato, da poco uscito in traduzione italiana a cura di rav David Gianfranco Di Segni (Giuntina, pp.474, 55 euro), troverà queste pagine davvero toste, un eufemismo per dire molto difficili. Con ben poche aggadot o sezioni narrative, i cinque capitoli della Mishnà commentati in 40 dappim o fogli talmudici che compongono Betzà sono una discussione dopo l’altra tra molte decine di rabbi: amoraim che citano altrettanti tannaim, nel tentativo di giungere a trovare la quadra tra le opinioni della scuola di Shammai, in questa materia sorprendentemente facilitanti ossia meno rigide, e le opinioni della scuola di Hillel, che sta su posizioni più restrittive, più stringenti. Si fa qui ricorso, inoltre, alla logica deduttiva e all’analogica più che all’arte della citazione scritturale (e questo si spiega perché, entrando nel dettaglio dell’halakhà, molte di queste norme sono state fissate dai maestri stessi, sono Torà de-rabbanàn, e non Torà de-oraità, ossia dal Sinai). Infine, per complicare le cose, in diaspora certi giorni festivi sono doppi, ma non in eretz Israel (ad eccezione di Rosh hashanà, che sono due giorni anche in Israele), e come ci si regola quando Yom Tov precede o segue lo Shabbat… Tra domande, spiegazioni, ipotesi, obiezioni, contraddizioni (apparenti o reali), dispute su motivazioni e intenzioni, c’è da perdersi. E allora: benvenuti nel Talmud al suo meglio! Un corpus letterario-giuridico-religioso che non ha eguali nella tradizione occidentale e che, come accennato, non va letto da soli ma va studiato con un maestro. Ma torniamo all’uovo che qui è ‘un caso di studio’.
Betzà she-noldà be-yom tov… un uovo deposto in un giorno festivo, è permesso mangiarlo oppure no? Dipende dalla gallina, ovviamente. Non è una battuta, sebbene sia inevitabile alludere al noto paradosso se sia nato prima l’uovo o chi l’ha deposto innescando una circolarità blindata. Infatti nel paradosso si cerca di individuare un’origine ontologica inverificabile; nel Talmud invece la discussione è ortopratica – si mangia oppure no? e in base a che? – perché si tratta di capire cosa si può ‘fare’ in un lasso di tempo che la Torà separa da tutti gli altri tempi (Shabbat e le feste comandate) e che viene qualificato dal ‘non fare’. Se è vero, come è vero, che l’essere umano è per sua natura homo faber, sempre intento a fare qualcosa, creare, usare utensili, manipolare il mondo in un modo o nell’altro, allora capire cosa non si può fare significa indagare semplicemente la natura umana. Poiché quel ‘non fare’ è un precetto divino, una mitzwà, uno dei dieci comandamenti (il quarto), la questione attiene non solo all’antropologia o conoscenza dell’essere umano, ma anche alla teologia. Mangiare o astenersi dal mangiare di shabbat o in giorno festivo un uovo deposto in quel medesimo giorno è un caso specifico di un problema generale: quali sono i nostri limiti nell’uso del mondo; dove ci dobbiamo fermare per riconoscere che non tutto ciò che esiste esiste per il nostro mero consumo; in che misura le intenzioni con cui agiamo/facciamo qualcosa nel mondo non sono neutre ma dettano il senso delle nostre azioni, del nostro fare? Se considerate in questi termini, estremamente attuali, si intuisce che le lunghe e complesse discussioni tra le scuole di Shammai e di Hillel (che eviscerano l’edibilità di un uovo deposto nel giorno di festa) sono tutt’altro che questioni di lana caprina.
Per capire chi è l’essere umano in rapporto sia al mondo-tempo sia al mondo-spazio “secondo la Torà”, i maestri di Israele devono anzitutto capire come si differenzia lo Shabbat dalle altre feste sotto il profilo del ‘riposarsi’ ossia del senso della festa stessa. A tal fine essi hanno elaborato il concetto – ed elaborare un concetto è raffinata impresa intellettuale – di muqtzè, che significa “messo a parte” in quanto non utilizzabile nei giorni in cui certe azioni non vanno fatte in quanto non permesse dalla Torà. Se un’azione è proibita, anche lo strumento per compierla lo è: va messo da parte, anche se nella Torà non si fa menzione di tale strumento, perché il prenderlo in mano, persino il solo toccarlo, indurrebbe per abitudine o per distrazione a usarlo infrangendo così la norma sul riposo o sul non-fare una data azione. Dunque occorre lavorare di testa, di logica e di analogia, per stabilire cosa sia muqtzè, cosa vada “messo a parte” e cosa invece non vada “messo a parte”. Mangiare (e bere e copulare e costruire) sono azioni del tutto naturali, è natura; ma capire i modi giusti e i limiti e i confini di tali azioni è invece scelta etica ed espressione di libertà, in una parola: è cultura! Da qui la ricerca della direzione da dare al nostro agire: usare o mangiare o manipolare qualcosa resasi disponibile al di fuori delle nostre intenzioni (come un uovo di giornata) non tocca il senso del nostro rapporto con il mondo? Non va capito anzitutto nel suo contesto? Non sollecita una valutazione delle circostanze specifiche? Non esige anzitutto che quella novità sia studiata e capita in rapporto al nostra vocazione umana? È proprio quel che fanno i maestri di Israele nel trattato Betzà.
Il curatore rav David Gianfranco Di Segni lo spiega con un esempio chiaro e concreto: “Il concetto base è che di Sabato e durante le feste ci si deve comportare in modo diverso dai giorni feriali. Si toccano solo gli oggetti che sono permessi e che sono stati destinati intenzionalmente all’uso. Solo per mezzo di un distacco completo e concreto dalle modalità dei giorni feriali si riuscirà a entrare nello spirito e nella dimensione speciale creati dallo Shabbat e dallo Yom Tov. Per fare un esempio dalla vita quotidiana moderna, se si permettesse di toccare il cellulare, sarebbe molto difficile per la maggior parte delle persone astenersi dall’usarlo, un’attività che – come l’uso di tutti gli strumentri elettrici – è vietata di Shabbat e nei giorni festivi”. Un estremo? Niente affatto. La libertà ha il suo prezzo, e che noi si sia diventati tutti un po’ schiavi della tecnologia è un fatto la cui miseria può essere misurata solo dall’opzione (psicologicamente salvifica) di astenercene almeno un giorno su sette, per godere di più la vita e capire il senso più vasto e profondo del mondo. Tutto ciò costituisce la posta in gioco nella discussione talmudica sull’edibilità, durante le feste, di un uovo di giornata!
Ma perché proprio un uovo? A parte il fatto che nel testo talmudico si parla anche di fichi secchi, di pesci, di lenticchie e di molte altre cibarie, l’uovo resta un alimento altamente simbolico: rimanda al processo evolutivo della vita, che nella gallina da ovulo fecondato si sviluppa in embrione, poi in pulcino, e di nuovo in volatile; è curvo, quasi sferico, senza angoli, senza apparente inizio e fine, come (sempre in apparenza) il mondo; per contrappasso è stato usato come consolazione alla morte, offerto a chi è in lutto, perché in realtà allude alla rinascita, alla resurrezione (è un indice di primavera, da qui l’uso pasquale); a Pesach sta sul piatto dei cibi rituali insieme alla zampa d’agnello, in memoria delle offerte che si facevano al Tempio… Pars pro toto, l’uovo è simbolo della vita e della morte, i due poli valoriali che ispirano la Torà e l’halakhà: scegliere la vita e non farsi contagiare dalla morte. Come non restare ammirati per il fatto che un intero trattato del Talmud si intiloli ‘Uovo’ e che i maestri lo portino ad esempio e ne discutano nei minimi dettagli, al fine di essere sempre più fedeli allo spirito della Torà?
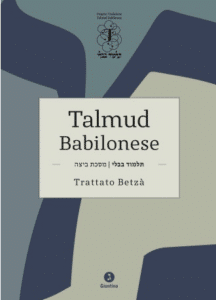
Massimo Giuliani insegna Pensiero ebraico all’università di Trento e Filosofia ebraica nel corso triennale di Studi ebraici dell’Ucei a Roma
