Che significa globalizzazione? Come si esce dalla crisi planetaria attuale? Il giornalista israeliano lo scrive in “Revolt”, il suo libro appena uscito per La nave di Teseo
“Nel mondo post-bipolare i conflitti riguardano meno l’ideologia (comunismo vs. capitalismo liberale, per esempio) e più spesso l’identità etnica e religiosa”.
Diversamente: “Le guerre odierne riguardano meno ciò che pensi, o che un paese vuole da un altro, ma più chi sei” [p. 312].
Potremmo condensare gran parte della riflessione di Revolt di Nadav Eyal in queste poche righe. Non credo che sia sufficiente, anche se non sarebbe sbagliato.
Credo che per fare i conti con le molte questioni che Revolt propone, occorra ad un tempo adottare uno sguardo lungo, ma anche individuare dove sta il nucleo generativo del suo tormento.
In sintesi: il nucleo generativo dello sguardo lungo sta nella profondità della crisi che attraversiamo; il nucleo generativo credo che Eyal lo individui nel punto di crisi del paradigma societario della sua realtà politica, sociale e culturale, ovvero Israele. Non riguarda la questione guerra/pace, bensì quella relativa al patto sociale per lo sviluppo.
Considero velocemente la prima questione e poi la seconda.
Quando nel 2017 Roberto Festa racconta in presa diretta il malessere dell’’America nel suo L’America del nostro scontento, l’opinione pubblica in Europa non ha la consapevolezza che deve prendere la misura con una trasformazione che forse ha il suo punto nevralgico in quello scenario, ma in realtà riguarda anche la sua identità profonda così come si è definita nel lungo Secondo dopoguerra.
Quel libro dice una cosa molto semplice: occorre riprendere la misura della realtà.
Ancora quattro anni dopo, con l’incertezza di sapere se per davvero ne siamo fuori o meno, Nadav Eyal ritorna con lo sguardo lungo di un ventennio e scavare nel solco profondo da cui anche quell’America veniva fuori e ci porta dentro una condizione, questa volta non solo americana, ma planetaria, con cui ancora facciamo fatica a prendere la misura.
Dove siamo? Eyal propone verso la fine del suo libro un parallelo che non mi convince molto (a differenza dell’analisi concreta che illustra ampliamente nel corso del libro che invece trovo non solo convincente, ma anche molto “puntuta”) e che forse va preso solo come spunto, o forse perché non abbiamo modelli storici di sconvolgimento capaci di avvicinarsi a quello attualmente in corso. Scrive Eyal alle pagine 413 e 414:
Il momento attuale non è simile, come alcuni hanno suggerito, allo scoppio di una rivoluzione, quale fu per esempio la Rivoluzione d’ottobre del 1917 (..) Se un qualche parallelo può essere significativo, quello a cui stiamo assistendo non è dunque la Rivoluzione d’ottobre, quanto qualcosa di simile alla rivoluzione che la precedette di pochi mesi, a febbraio. Fu allora che lo zar abdicò, la monarchia fu abolita i soviet (i consigli dei lavoratori) furono stabiliti e venne data forma a un governo provvisorio a guida della Russia. Ci fu poco spargimento di sangue, in confronto a quello che avvenne poi con la guerra civile, ma il sentire di un’imminente carneficina era nell’aria. La rivoluzione di febbraio sovvertì così a fondo il sistema politico che i radicali furino in gradi di organizzarsi e attaccare. Lenin poté salire a bordi dell’ormai leggendario treno sigillato con cui attraversò la Germania del Kaiser e fece ritorno in Russia, «come un bacillo della peste”, così lo definì Winston Churchill, dove guidò il colpo di stato.
Credo che la dinamica del febbraio 1917 sia molto diversa, con una solitudine del sistema di potere dello Zar e un distacco anche delle strutture che a lungo ne hanno mantenuto saldo il potere (l’esercito per primo). In breve, non mi pare di individuare nella condizione attuale un vero e proprio parallelismo. Ciò non toglie che gli elementi di fondo della crisi in sé ci siano e che forse l’occhio non generico di un giornalista, ma di un osservatore politico che muove il suo sguardo a partire dalla crisi politica del suo paese (Israele, tre elezioni in due anni, la non possibilità di una vera e propria classe dirigente alternativa, un primo ministro che rappresenta una capacità politica di tenuta, ma anche di cattura dell’opinione pubblica) certamente consente di dare una visione su alcuni punti della crisi che ci attraversa da tempo, con una sensibilità specifica.
Il tema dunque è il paradigma complessivo della crisi. Per esempio: processi di disoccupazione, spostamenti migratori consistenti; redistribuzione di popolazioni con abbandono e spesso decadenza strutturale di aree fino a un ciclo industriale fa, ovvero inizio XXI secolo (uno per tutti: si vedano le pagine dedicate alla “caduta” verticale di Detroit).
Ma poi quel paradigma è lavorato a partire da quelli che sono per Eyal i punti di frizione della crisi, anche sulla scorta della percezione del dato di crisi che egli ha nel suo paradigma risetto al contesto sociale, politico, e culturale che lo ha formato. Ovvero Israele.
Da questo punto di vista il libro ha un capitolo nodale, strutturale che probabilmente funziona da generatore. È il capitolo 12 quello che ha per titolo “L’umanità è il Titanic” [pp. 279-303].
In quelle venti pagine ci sono, credo, molti dei vettori che hanno messo in moto lo sguardo puntuto di Eyal.
Qualcosa è venuto meno, scrive all’inizio di quel capitolo Eyal. Si è invertita la curva demografica delle realtà che hanno segnato lo sviluppo economico, sociale e culturale nel corso del’900. Far nascere bambini non è più un investimento, non rappresenta una possibilità di futuro ed è sanzionato nel tempo presente (per esempio sul piano del lavoro). Non solo, la somma algebrica di (1) crollo della fecondità; (2) crescita della longevità (e dunque aumento della spesa sanitaria) e (3) declino della partecipazione alla forza lavoro minacciano il sogno di pensionamento e dunque l’aspettativa di soddisfazione.
Questi tre fattori, insiste Eyal, alimentano l’estrema destra, aumentano l’angoscia del possibile meticciato culturale delle società (che queste componenti politiche e culturali vivono come perdita della propria identità storica) e questa componente si associa a un secondo gruppo di questioni che connettono la propria condizione attuale a investimento e responsabilità nel ruolo dei genitori. Per cui una delle cause del crollo delle nascite è essenzialmente il non volersi prendere la responsabilità di crescere figli (un tratto su cui con acutezza insiste Jonathan Sacks nel suo Moralità nel capitolo dal titolo “La famiglia fragile”, p.83 e sgg.).
Il tema dunque è quale patto per domani vogliamo e quale immagine di società abbiamo nel nostro progetto individuale e collettivo e infine dove stanno i nodi della crisi che connette individuo e società in relazione alle realtà sociali, culturali, emozionali all’interno delle quali o rispetto alle quali si è formato. Ovvero dove si colloca il punto di rottura tra generazioni. E dove e come riprendere quel filo.
Consideriamo un diverso tema, ancora correlato a questo, ovvero il futuro dei sistemi di società fortemente minacciati dallo stile di vita e dal tema dei consumi. In altre parole, il tema delle conseguenze di non prendere la globalizzazione sul serio, e di considerarla o una scocciatura rispetto alle nostre consolidate consuetudini, o come un “impiccio” che viene a disturbare il nostro ordine di vita quotidiano.
Il tema è molto semplice, (apparentemente): come abbiamo fatto di tutto nel nostro tempo (più o meno negli ultimi trent’anni, ma secondo l’autore il tema è aperto di fatto con le conseguenze del Secondo conflitto mondiale, e dunque con il 1945 che Eyal considera non un problema “europeo”, bensì “globale”) per non prendere in carico le sfide che assumere il mondo come “casa” ci obbligava a fare.
Ne sono discese molte cose, compreso la rivolta nazionalista di questi ultimi decenni (in tutte le sue variabili: sovranismi, nuove forme del fondamentalismo religioso, populismi in tutte le loro diverse variabili, ….). Il punto che unisce tutte queste diverse pratiche politiche connesse con i sentimenti è sostanzialmente uno, sostiene Eyal: un radicale rifiuto di prendere le misure per rimodulare il nostro agire nel presente (privato e pubblico, singolare e collettivo) per dare nuovo statuto e prendere davvero in carica l’idea di futuro possibile, auspicabile.
La storia del futuro delle Maldive – un’area in cui tutta l’economia – ma in realtà tutta la vita dei suoi abitanti -uso la parola “vita” nel senso letterale del termine – si sostiene su un equilibrio precario tra presenza umana – e dunque azione concreta dell’uomo – e barriera corallina (e dunque mantenimento dei fattori che non ne infrangano gli elementi che ne consentono il mantenimento e la radicale incuria ai temi dell’ambiente nei comportamenti collettivi), è esemplare: come dice l’ex presidente delle Maldive Mohammed Nasheed a Eyal (pp. 133 e sgg.). Lo riporto qui perché quello scambio tanto secco quanto drammatico, semplicemente dice dove sta il problema, senza dare possibilità a “vie di fuga” né salvifiche né “benaltriste”:
Le nostre spiagge sono molto erose. C’è una diminuzione del pescato perché i pesci non sono più in superficie come un tempo. Se le temperature dell’acqua continueranno a salire… Smetteremo di esistere. Le barriere coralline moriranno e le nostre isole collasseranno, tutto il nostro habitat collasserà. […]” Quando gli chiedo che cosa pensa di coloro che negano il cambiamento climatico, dà una dura risposta. “Non puoi contrattare con la scienza. Non puoi fare un accordo con i fatti. Abbiamo duemila anni di storia scritta. Ci è difficile pensare di poterci estinguere in questo modo. Non intendo morire a causa del cambiamento climatico. Rifiutiamo di morire. Vogliamo vivere.
Non ci sono molte alternative, dunque. Ma complessivamente stiamo facendo di tutto per evitare di confrontarci con questa partita e tutte le risposte orgogliose che sono proposte: dalla riscoperta delle virtù autoriferite al gruppo nazionale di appartenenza, alla forza dell’orgoglio dell’appartenenza a una qualsiasi forma di credo religioso trasformato in arma di uccisione di massa (al centro del quale sta l’Io come unica misura del mondo) l’unico alfabeto che siamo in grado di adottare – e dunque l’unica lingua che sappiamo parlare è quella propria dell’appartenenza stretta (singolare o plurale , non fa molta differenza).
Alle volte la realtà presenta il conto nella maniera più imprevista e come la satira efficace (per esempio quella di Jonathan Swift) stravolge la logica delle nostre convinzioni rovesciandone completamente il senso e costringendoci a prendere in carico la realtà dei fatti, che è sempre più spiazzante delle nostre solide convinzioni. Quando questo accade la possibilità di salvezza sta nella prontezza di reagire, ovvero nel comprendere che il reticolo concettuale su cui si è costruito un comportamento collettivo deve essere radicalmente ripensato.
Serve un nuovo modello finanziario sostenibile, dove l’ambiente e i diritti siano al centro. Per quanto riguarda il futuro, anche dell’Europa, crescita e politiche pubbliche devono andare di pari passo per creare occupazione e, in questo modo, diminuire le disuguaglianze.
Lo ha detto circa due anni fa (maggio 2019) Amartya Sen riflettendo sul senso di una diversa preoccupazione nell’agire economico. E ha aggiunto: “Quando si parla di crisi del 2008 la Bce ha dato un esempio di leadership non ottimale. Non c’era bisogno di austerity, quanto di un coordinamento robusto: l’occupazione è peggiorata, il Pil è calato in diversi Paesi e nel tempo si è capito quanto sia stata negativa”.
Quando è iniziato questo processo? E cosa sta al fondamento e all’origine della condizione di fragilità del progresso?
Ce lo chiediamo spesso. Eyal ci fornisce delle risposte, ma implicitamente credo ci fornisca anche un paradigma di lettura. Ovvero la sensibilità di ciascuno lettore, ma anche di ciascun autore, muove sempre da un grumo di questioni o di incertezze che hanno un riscontro diretto con il proprio vissuto o con la realtà in cui si è cresciuti e ci si è formati. Si può avere uno sguardo cosmopolitico, ma la storia di un individuo e la sua intelligenza è sempre l’effetto e la conseguenza delle scale di valori, di temi, di preoccupazioni su cui ha preso forma la propria persona tra infanzia e età adulta. Poi certo si cresce, si cambia prospettiva, si modificano e si incrementano strumenti, tecniche, riferimenti e dotazioni culturali, ma la propria persona è il luogo dove si nasce, la scala di valori all’interno della quale si cresce e con cui magari si fanno anche i conti con radicalità, nel tentativo di liberarsene e adottarne di nuovi. Ma la formazione personale è lì a dire e a indicare la matrice originaria delle proprie inquietudini o delle proprie incertezze. È per questo che non esistono intellettuali spersonalizzati del proprio carattere nazionale e intellettuale che si riconoscono solo nell’appartenenza al proprio gruppo. La vicenda è più complicata e comunque è affascinate e coinvolgente quando la non fuoriuscita da sé è anche la ricerca di punto di equilibrio o si condensa in un patto per lo sviluppo che abbia una dimensione universalistica.
La scommessa di Nadav Eyal è esattamente in questa difficile, ma non impossibile “quadratura del cerchio”.
Per concludere (almeno qui):
questo libro documenta quanto sia davvero fragile il progresso che abbiamo raggiunto e testimonia del rischio che la civiltà possa volgere anche in tempi brevi verso le tenebre. Quanto alla strada che si deve percorrere per migliorare le cose, passa prima di tutto per un cambiamento della politica. Quella del XX secolo sta morendo, come ha dimostrato la pandemia in corso che ha reso evidente quanto sia ormai irrilevante, vuota. Non è riuscita a prevenire la crisi finanziaria del 2008, non riesce ad affrontare il cambiamento climatico in modo efficace, e ora guarda al contrasto al Covid-19 attraverso strutture di potere locali e nazionali poco efficienti. La Storia è realistica per natura: un mondo globalizzato è il nostro modo migliore per sopravvivere. E intendo in senso letterale, fisicamente. Perciò abbiamo bisogno di istituzioni globali dotate di potere reale. Prima di tutto si devono però far riflettere le persone sul fatto che se la globalizzazione non è un «villaggio ideale» non è neppure un male in sé.
Secondo il giornalista israeliano Nadav Eyal, c’è un filo rosso che lega fenomeni che siamo abituati a considerare molto lontani tra loro: il crescere del nazionalismo nei paesi dell’occidente è legato al rafforzamento del controllo che il governo cinese opera sui suoi cittadini; l’estinzione di molte specie animali e vegetali non è separata dal fondamentalismo; il sentimento d’insicurezza che domina una gran parte della classe media mondiale è legato alla crisi delle nascite; la diffusione delle fake news alla gestione delle migrazioni e alle proteste populiste.
Il legame sta nel fallimento dell’ordine globalizzato che si è stabilito dopo la Seconda guerra mondiale, un sistema politico ed economico che, pur avendo avuto il merito di migliorare le condizioni di vita di moltissime persone, ha fatto aumentare in modo esponenziale le disuguaglianze e ha scatenato la catastrofe climatica.
Alternando reportage dai luoghi in cui questi processi sono particolarmente visibili, ricordi personali di appartenente a quella “generazione x” che ha visto l’ordine sgretolarsi e studi storici e geopolitici, Eyal invita a considerare le ragioni di complottisti, rivoltosi e noglobal che, spiega, condividono molte più cose di quanto sembri. E suggerisce che l’unico modo per uscire da questa crisi delle crisi è immaginare un governo globale capace di rispondere a bisogni sempre più impellenti.
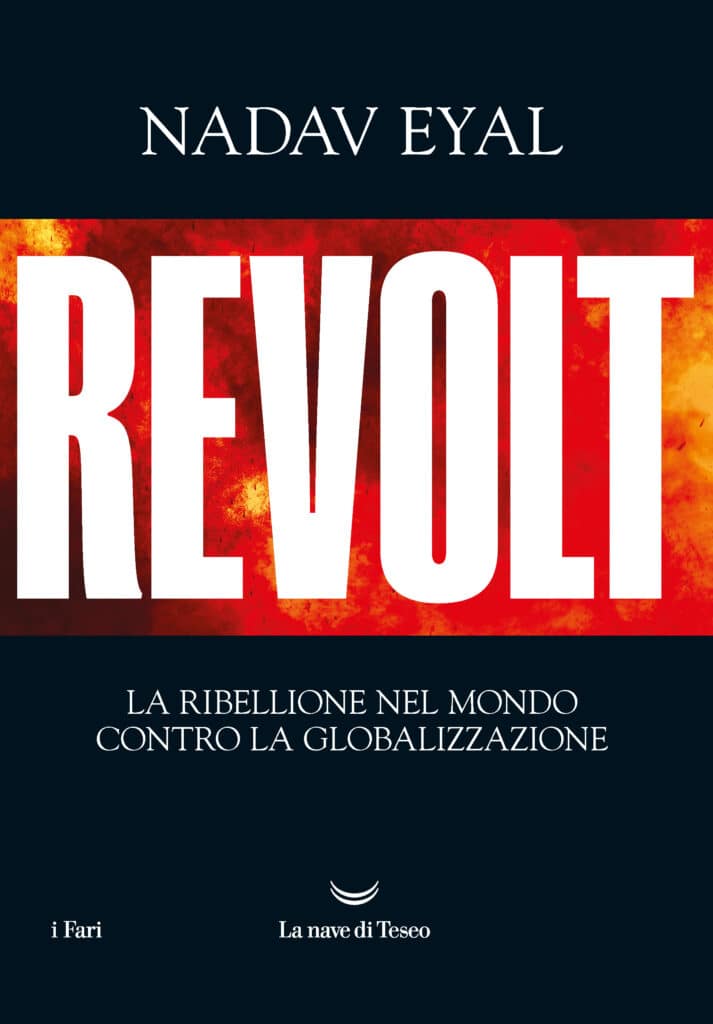

Grazie di questa che non è solo una recensione – suggerisce già un metodo per indagare la società e il nostro posto nella comunità dei viventi. Ovviamente lèggerò il libro, una prima osservazione, e una ipotesi: suggestivo e in qualche modo esemplare che la terra d’Israele / eretz Israel sia ancora il laboratorio a cielo aperto di un cambiamento epocale. E: il declino del pensiero illuminista, come causa e motore del declino globale ( quasi ogni luogo è ormai ‘occidentale’… ) ? Ancora grazie a Bidussa e a JoiMag.