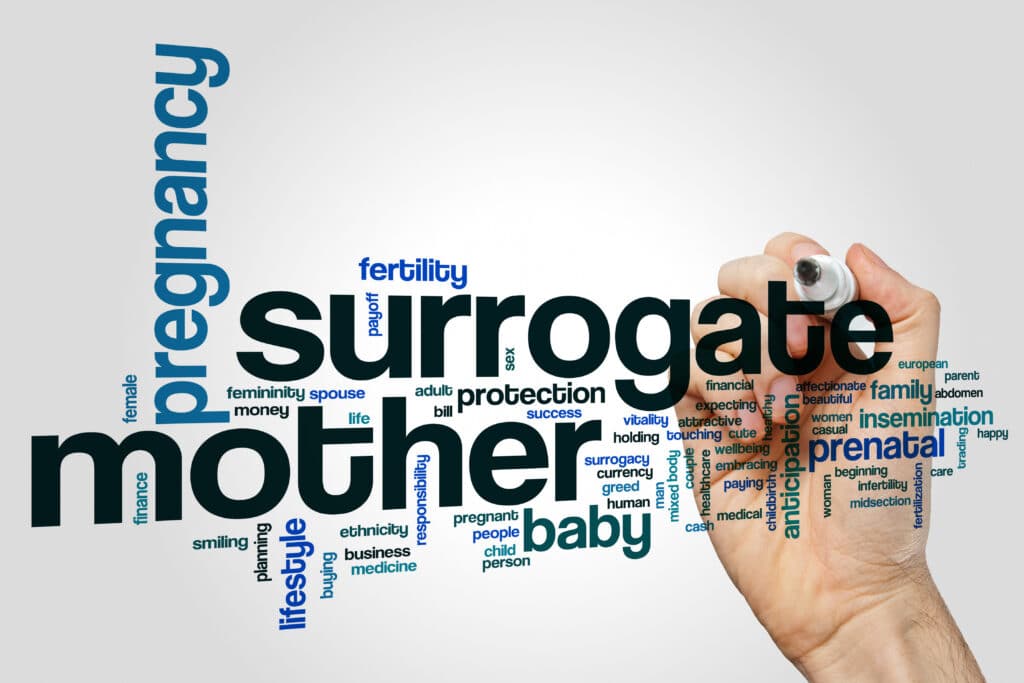
Tra il valore della famiglia e quello della libertà: rassegna stampa tematica
Sappiamo che creare una famiglia costituisce un valore centrale nel pensiero ebraico: crescere dei figli è una mitzvah. Ma è una mitzvah anche combattere qualsiasi forma di oppressione della libertà. Partendo da questi presupposti, quali posizioni aspettarsi dall’ebraismo sul ricorso alla maternità surrogata?
La questione chiama a numerose riflessioni: di tipo etico, sociale, religioso.
Gli argomenti contro: un coro pluridenominazionale
Il rabbino conservative Elliot N. Dorff – professore di filosofia presso l’American Jewish University in California – presenta su My Jewish Learning le argomentazioni contrarie alla maternità surrogata di tre rabbini. Il primo è l’ortodosso Immanuel Jacobovits (1921-1999, rabbino capo del Regno Unito prima di Rav Sacks) considerato uno dei fondatori della bioetica ebraica applicata al campo medico. Sulla pratica della maternità surrogata, Rabbi Jacobovits nel suo trattato Jewish Medical Ethics si esprime in questi termini: “Usare un’altra persona come incubatore e poi portarle via il bambino in cambio di soldi è una degradazione rivoltante della maternità e un affronto alla dignità umana”.
Abbiamo poi il rabbino conservative Daniel Gordis, il quale guarda soprattutto alla situazione della madre surrogata: la gravidanza, da portare avanti per conto di altri, rappresenta una limitazione alla sua libertà, sia nella sfera individuale che all’interno della vita di coppia e famigliare e va quindi, in ultima analisi, considerata come una violazione dei suoi diritti, una forma di schiavitù che l’etica ebraica non può permettere. Rabbi Gordis si preoccupa inoltre degli effetti sociali della maternità surrogata, sostenendo che essa accentua le differenze tra coppie ricche e povere, tra la coppia che paga e la madre surrogata che riceve il pagamento.
Infine, il rabbino reform Marc Gellman esprime contrarietà partendo da un altro punto di vista ancora: la vita matrimoniale, che deve essere rigorosamente fondata sulla monogamia. Benché il ricorso alla maternità surrogata non possa essere accostato all’adulterio, introduce comunque nella coppia una sorta di terzo elemento, che potrebbe portare alla perdita dell’equilibrio e dell’armonia. In aggiunta, dalla prospettiva della madre surrogata, la pratica costituisce un rischio ingiustificato per la salute, che viola il principio ebraico di non compiere azioni che rischiano di attentare alla vita.
Gli argomenti a favore: crescete e moltiplicatevi
Un’altra rassegna sulle declinazioni del pensiero ebraico riguardo la maternità surrogata si trova sul sito dell’Istituto Schechter (istituzione accademica con sede principale a Gerusalemme e altri due campus a Tel Aviv e Philadelphia, affiliata all’ebraismo conservative) e porta la firma del suo Presidente, Rabbi David Golinkin.
Pioniere di una visione favorevole alla pratica della maternità surrogata, scrive Golinkin, è stato Rabbi Elie Kaplan Spitz, della Congregazione Bna’i Israel di Tustin, California, alla fine degli anni ’80. Perché dire sì a questa possibilità? Perché offre un modo alle coppie in difficoltà di adempiere alla mitzvah Peru urevu, ossia “Crescete e moltiplicatevi”.
Il testo biblico, dopotutto, abbonda di esempi di “soluzioni creative” di fronte al bisogno di assicurare una discendenza. In quest’ottica, è possibile trovare delle corrispondenze tra la pratica moderna della maternità surrogata e la figura della shifhah, l’ancella della moglie sterile del patriarca di turno: Agar, Bilha, Zilpa. Le corrispondenze si trovano su tre livelli: 1) il ricorso a una “terza parte” è permesso come ultima risorsa per garantire una discendenza; 2) viene riconosciuto il ruolo della madre intenzionale (Sara, Rachele, Lea) e non di quella effettiva; 3) i figli nati da queste unioni (Ismaele, Dan, Naftali, Gad, Asher) sono a tutti gli effetti eredi legittimi del padre.
Golinkin tuttavia, conclude l’articolo esprimendo opposizione al pensiero di Spitz: noi oggi, scrive, pratichiamo un ebraismo rabbinico, non biblico e la Halakhà ha abolito la figura della shifhah. Inoltre, passato e presente non sono paragonabili: alla madre surrogata il bambino viene sottratto, mentre nella Bibbia Ismaele e gli altri vengono allevati dalle loro vere madri, che restano a vivere presso la casa patriarcale… almeno finché i rapporti non si guastano, come succede ad Agar e Sara: una prova ulteriore che il “terzo elemento” non fa bene all’armonia della famiglia.
Chi è la madre?
Già, questa è la domanda centrale. L’ebraismo, halachicamente parlando, is all about the mother. Chi è la madre di un bambino nato da questa pratica? La donna che dona l’ovulo o la donna che porta avanti la gravidanza e partorisce? Ci sono diverse posizioni, ma quella prevalente riconosce il ruolo di madre alla seconda, per il legame che si crea nei nove mesi della gestazione e poi durante e dopo il parto. Essendo proprio questa la posizione adottata dal Rabbinato israeliano, ne consegue il fatto che il bambino di una coppia ebraica nato da madre surrogata non ebrea, non è ebreo. E ciò può essere all’origine di situazioni problematiche. Ne parla Yifat Erlich su Ynet, raccontando la storia di Sigal ed Erez, una coppia israeliana il cui bambino, Gilad, figlio biologico di entrambi ma partorito da madre surrogata non ebrea, viene registrato all’anagrafe come “senza religione”.
Sigal ed Erez trovano comunque un mohel disponibile a praticare la circoncisione e si rivolgono al Rabbinato per ottenere il ghiur katan, la conversione del minore. Un percorso difficile:
“Quando finalmente abbiamo ottenuto l’appuntamento, non abbiamo nascosto il fatto che siamo laici, siamo in un Paese libero”, dice Sigal. Dall’incontro emerge però che il Rabbinato chiede, per dare l’assenso al ghiur katan, l’adozione di uno stile di vita strettamente religioso: “La loro intransigenza mi faceva diventare matta: questo bambino è stato creato dal mio ovulo e nessuno può mettere in dubbio il fatto che sono ebrea. […] Tornavamo da ogni incontro frustrati e in lacrime. Siccome il cognome di mio marito è Katz – che significa Cohen Tzedek, “sacerdote giusto” – il Rabbinato non permetteva neanche che lo passasse a Gilad [I Cohen non possono sposarsi con dei gherim, perciò un gher non può chiamarsi Cohen]. Quando ce lo dissero, mio marito perse il suo sangue freddo, ci mancò poco che rovesciasse il tavolo. Capimmo che a loro non importava se Gilad fosse rimasto non ebreo”. Alla fine, racconta la giornalista, Sigal ed Erez hanno ottenuto la conversione di Gilad rivolgendosi a Giyur K’Halacha, un’organizzazione ortodossa non governativa. Non riconosciuta, però, dal Rabbinato ufficiale: significa che Gilad, quando sarà grande, dovrà andare all’estero per potersi sposare.
Laureata a Milano in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, ha studiato Peace & Conflict Studies presso l’International School dell’Università di Haifa, dove ha vissuto per un paio d’anni ed è stata attiva in diverse realtà locali di volontariato sui temi della mediazione, dell’educazione e dello sviluppo. Appassionata di natura, libri, musica, cucina.

Ottimo