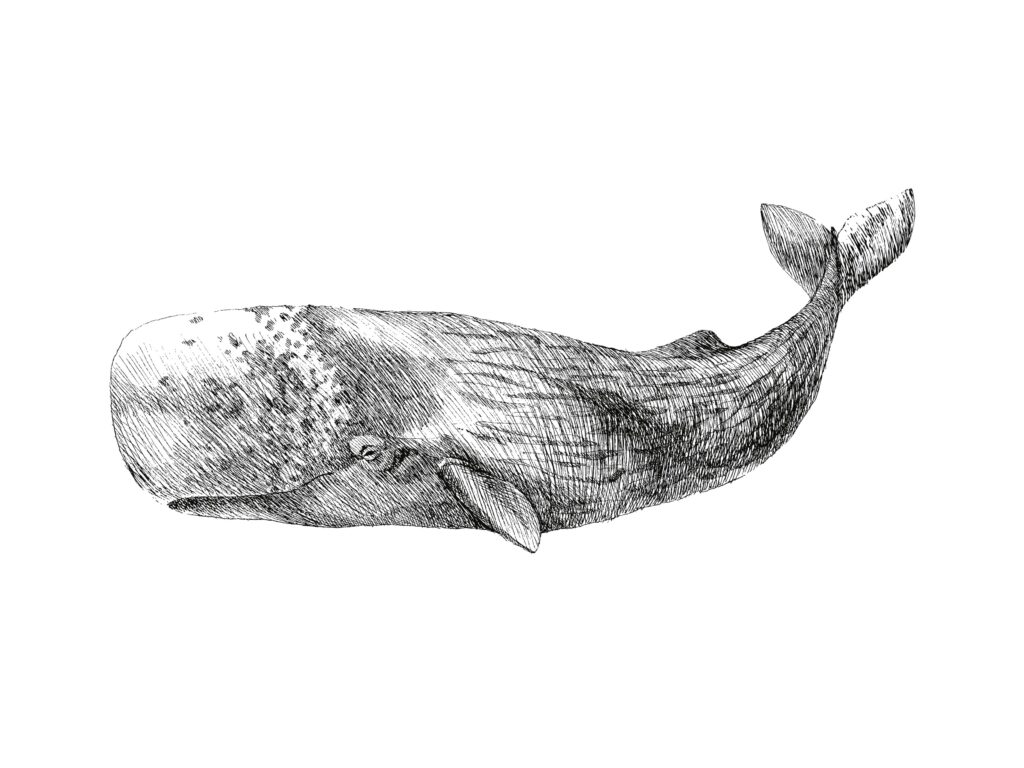
Di capitani, ramponieri, mostri e ossessioni umane antiche come il mondo e ben narrate nel Tanakh
Leggete quest’opera tenendo a mente la Bibbia e vedrete come quello che vi potrebbe anche parere un curioso romanzo d’avventure, vi si svelerà invece per un vero e proprio poema sacro cui non sono mancati né il cielo né la terra.
L’opera è Moby Dick, le parole di Cesare Pavese. Del romanzo in tutti i sensi oceanico di Hermann Melville l’intellettuale di Santo Stefano Belbo è stato autore nel 1930 della prima celebre traduzione italiana, pubblicata due anni più tardi dall’editore Frassinelli come titolo inaugurale di una collana a vocazione internazionale diretta da Franco Antonicelli, in controtendenza in anni di crescente autarchia culturale imposta dal regime fascista. Nuove traduzioni sono state fatte nei decenni successivi, anche se la versione di Pavese continua oggi a essere ristampata. A centosettanta anni dall’uscita del libro negli Stati Uniti (1851) e a centotrenta dalla morte dell’autore (1891), proponiamo un breve viaggio nella fitta rete di rimandi e allusioni di ascendenza biblica su cui il capolavoro di Melville è strutturato come forse nessun altro libro.
Giona baleniere
Se prendiamo in mano il Tanakh e leggiamo le parti che si soffermano sull’insediamento ebraico nella Terra di Israele, per esempio i libri dei Re e dei Giudici, ci rendiamo presto conto della quasi assenza dell’elemento marino. La civiltà ebraica antica è saldamente continentale, i suoi centri sono sulle alture della Giudea e della Samaria e quando il riferimento va alle città costiere viene accompagnato da un giudizio negativo: sulla costa infatti vivono popoli idolatri dai quali si invita a stare lontano, anche tramite l’esempio tragico di chi come Sansone ha fatto diversamente. Il mare corrisponde a un orizzonte ignoto ma temuto, popolato dalla notte dei tempi da creature gigantesche come il Leviatano. Anche i protagonisti dell’epica di Melville, balenieri della East Coast, temono le acque profonde dell’oceano; ne sono però allo stesso tempo attratti irresistibilmente, al punto da intrecciare le proprie vite alle possibilità e ai pericoli dell’elemento acquatico. Moby Dick, romanzo di natura enciclopedica e tassonomica, si sofferma sulle origini mitiche della caccia alla balena, cioè il Leviatano descritto nel libro di Giobbe come abitatore degli abissi dalla creazione. Lo stesso Leviatano è per Melville il mostro che tiene prigioniera Andromeda sullo scoglio di Yoppa (Jaffa), va dunque attribuito all’eroe liberatore Perseo il titolo di primo ramponiere. E guarda caso proprio da Yoppa Giona si mette in mare, nel tentativo anodino di sottrarsi al comando divino. La storia che segue e le sue rivisitazioni moderne – la più celebre quella di Collodi in Pinocchio – sono note. Dalla vicenda di Giona baleniere suo malgrado deriva quella di san Giorgio, che combatterebbe non un banale drago terrestre bensì una ben più imponente balena. E poi, nei vasti territori del mito greco e dei Veda, Eracle e Visnù. Giona, Perseo, san Giorgio, Eracle, Visnù: “Quale altro club potrebbe vantare simili soci fondatori?”.
Ismaele, Bildad e Peleg
I tre protagonisti principali del romanzo sono il capitano Achab, la balena bianca e il narratore Ismaele. Sui primi due, legati da un vincolo strettissimo, diremo qualcosa più avanti, al terzo invece appartiene l’esordio, tre parole su cui sono stati versati letteralmente fiumi di inchiostro. Call me Ishmael, chiamatemi Ismaele, è un appello al lettore e un richiamo alla natura profetica del libro, testimonianza di un sopravvissuto che ha visto la morte in faccia ed è scampato. In Bereshit/Genesi Ismaele è il primo figlio di Abramo, cacciato con la madre schiava nel deserto dopo la nascita inattesa del figlio dell’alleanza Isacco. Nel deserto il figlio del rifiuto di Dio impara a sopravvivere, in solitudine, contro avversità di cui non è responsabile. E l’immensa liquida distesa dell’oceano non è forse un deserto ancora più vasto e silenzioso di quello sabbioso? In Moby Dick, in ogni caso, non solo i protagonisti ma anche i personaggi secondari hanno nomi e volti biblici. I due armatori che organizzano la spedizione, litigando costantemente, si chiamano Bildad e Peleg. Il primo, scrive Melville, è “un quacchero integrale” che legge continuamente la Bibbia, severo con sé e inflessibile con gli altri; il secondo un blasfemo che si diverte a provocare il socio in affari ma che dimostra maggiore comprensione per le esigenze dei marinai. Allo stesso tempo Bildad è anche, nel Tanakh, uno dei tre (finti) amici di Giobbe, il secondo a parlare e il primo ad alludere a una colpa di cui Giobbe si sarebbe macchiato, unico elemento a suo avviso in grado di spiegare le pene che soffre. Peleg, figlio di Ever e padre di Reu, compare nella genealogia di Abramo come colui ai cui tempi “la terra era divisa”. Seguendo la nota dell’edizione Disegni significa che al tempo di Peleg gli uomini si distribuiscono nelle varie parti della terra, allontanandosi gli uni dagli altri. Peleg è infatti un nome parlante, dalla radice palag, dividere. La caccia parte sotto gli auspici di un integralista e di uno scismatico.
La testa di Oloferne
Non solo i personaggi sono tratti dalla Bibbia ebraica, quella che per Melville è l’Antico testamento, ma anche le situazioni e le analogie che si dipanano nel corso del racconto. Qualche esempio tra le decine a disposizione. La macellazione sul ponte della nave di un capodoglio catturato viene avvicinata a un sacrificio compiuto “immolando diecimila buoi rossi alle divinità marine”, con riferimento al rito della mucca rossa descritto in Bamidbar/Numeri. Poco più avanti la testa della balena appesa a una gru è paragonata a quella di Oloferne che pende dalla cintura di Giuditta. Quando Melville spiega con minuzia di dettagli la fisiologia del capodoglio e si sofferma sulla testa piena di spermaceti, la descrive come il “sancta sanctorum” in cui penetrare è tanto difficile quanto pericoloso. E infatti il ramponiere indiano che sta raccogliendo a secchiate la preziosa sostanza oleosa per cui le balene vengono cacciate cade dentro l’enorme cadavere galleggiante e viene salvato per un pelo solo grazie all’eroismo di un collega. E così via per tutte o quasi le oltre cinquecento pagine del romanzo.
Achab, il leviatano
La storia di Moby Dick è la storia di un’ossessione e di un duello. Il capitano Achab fa un patto con quel diavolo che si è creato lui stesso e prende così il testimone dall’omonimo personaggio del primo libro dei Re che compie tali malefatte da finire ucciso da un dardo dopo un intero giorno di agonia e con i cani che gli leccano il sangue che sgorga dalla ferita. Il capitano erede del malvagio re è descritto fin da subito come “un grand’uomo senza alcuna religione, ma simile a un dio”. Un primo livello di lettura contrappone Achab e la natura (cioè la creazione) da lui sfidata in nome di una vendetta mortifera in cui non può che essere l’uomo a soccombere. La natura sfidata dall’uomo è qui espressione di una generica, panteistica vitalità, la stessa rappresentata nella scena in cui gli squali divorano il cadavere galleggiante del capodoglio (anticipando il più celebre dei racconti di Hemingway, Il vecchio e il mare). Di fronte al delirio ossessivo di Achab il lettore non può fare a meno di chiedersi chi sia davvero il Leviatano, chi il mostro. Ma la massa enorme della balena è anche un labirinto dove ci si può perdere, come capita al ramponiere che ci cade dentro, e ritrovare, come succede a Giona, Pinocchio e anche a Ismaele nella conclusione. E questa è una seconda lettura con cui la rigida opposizione uomo/natura comincia a sfaldarsi. Procedendo in questa direzione, è possibile interpretare la balena come simbolo di caos, confusione e brutalità irrazionale, un mostro degli abissi in fondo non poi tanto dissimile da Achab. Come l’antico monarca, secondo il libro dei Re, si costruisce una casa d’avorio, così il suo erede nel romanzo ha una protesi d’avorio, avorio di balena naturalmente, che gli consente di muoversi e gli ricorda a ogni passo l’oggetto del suo odio. La gamba d’avorio è altro, il nemico, ma è anche parte di lui. Come l’avorio, Moby Dick è il bianco, il bianco dell’innocenza, della grazia, della purezza e nello stesso tempo del vuoto, dell’accecamento, della morte. Si stabilisce così un rapporto di dipendenza tra cacciatore e cacciato, uomo e natura, idolatra e idolo. Achab è Achab perché Moby Dick è Moby Dick e viceversa. Non è pensabile l’uno senza l’altra. In questa ottica la balena bianca sembra molto lontana da un manifesto green, vicina piuttosto a un doppio perfetto dell’uomo. Come il computer Hal 9000 nel film 2001. Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, l’inumano è umano, ma davvero troppo umano.
“Era Rachele che piangeva sui figli scomparsi”
Quasi alla fine del romanzo, prima delle tre giornate di caccia con cui si compie il destino di Achab nel duello con Moby Dick, la nave incontra un’altra baleniera, la “Rachele”, il cui capitano riferisce di aver incontrato la balena bianca il giorno precedente e, nella lotta che è seguita, di aver perso il contatto con una delle lance da pesca, forse rovesciata dal mostro. Il capitano della Rachele chiede ad Achab di aiutarlo nelle ricerche dell’imbarcazione perduta, su cui era anche suo figlio. “Anche tu hai un figlio”, gli dice, “un figlio della tua vecchiaia”, con le stesse parole riferite ad Abramo. Ma Achab rifiuta e parte all’inseguimento della sua ossessione. Dopo il duello durato tre giorni e la tragedia finale, il solo a salvarsi è Ismaele grazie a una bara galleggiante utilizzata come scialuppa. “Il dramma è finito”, scrive Melville. “Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno è sopravvissuto alla distruzione”, come Giobbe. Ismaele ha visto il mostro ed è sopravvissuto. Come Giona, espulso dopo tre giorni dalle fauci del Leviatano; come il Gesù della tradizione cristiana, tornato dopo tre giorni dal regno della morte in quello della vita. È il testimone. Suo compito è raccontare la verità. E come il narratore biblico non arretra di fronte a nulla: non costruisce un mondo ipotetico – utopico – come gran parte della filosofia greca, impegnata a descrivere come il mondo dovrebbe essere. Riprendendo la tradizione ebraica antica, dice come il mondo è. Dopo essere stato portato dalle onde per un giorno nella bara, circondato da squali e falchi marini, ecco una vela e la salvezza. “Era Rachele che piangeva sui figli scomparsi, ma trovò soltanto un altro orfano”.
P.S.
Per chi è a Milano, fino al 19 dicembre il teatro Litta ospita Corrado D’Elia con il suo Io sono Moby Dick, spettacolo del 2017: “Torno a Moby Dick come chi torna a sé stesso”, scrive D’Elia nelle note di regia al nuovo spettacolo, “Per necessità quindi. E anche per urgenza. Lo spettacolo prende così una veste nuova, un nuovo respiro. E pur conservando la febbre e il furore della precedente edizione del 2017, si arricchisce di toni e di riflessioni più intime, più riflessive. Moby Dick è stato il primo spettacolo saltato per la pandemia. Anche per questo riprenderlo davanti ad un pubblico, accoglie un nuovo senso e una nuova urgenza. Al centro della ricerca c’è sempre lui, il teatro e il nostro lavoro di uomini e di donne di teatro. La nostra vita con le domande che inevitabilmente nascono dopo tanti anni di mestiere, le stesse che Achab rivolge a sé stesso”
