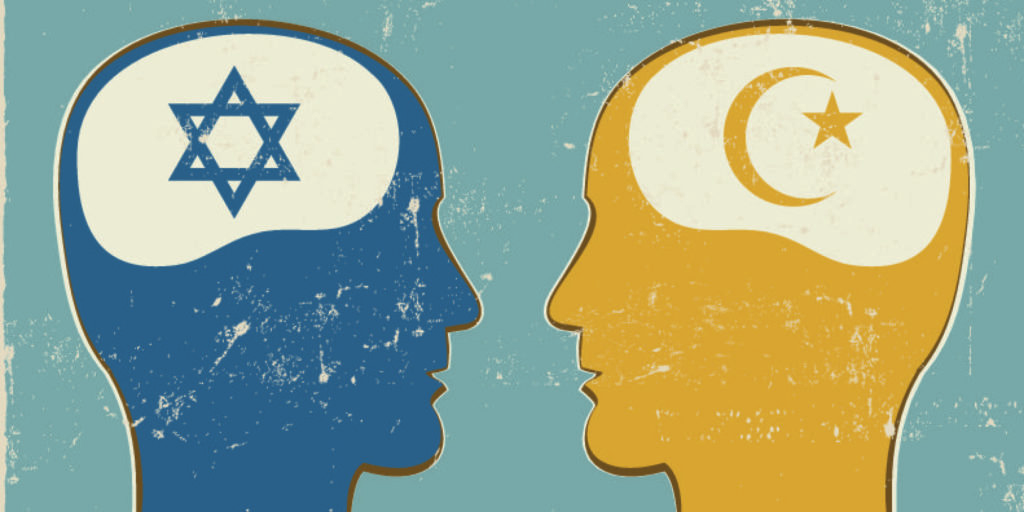E se tra le tante opportunità di questo nostro mondo iperconnesso ci fosse anche quella di cambiare la natura delle relazioni giudeo-musulmane? Abbiamo incontrato Rima: una conversazione lunga, come la più tipica delle cene orientali, che ti lasciano pieno e soddisfatto. E con un buon sapore in bocca.
Viviamo in un’epoca di grandi possibilità in termini di accesso a un’informazione diversificata e di esposizione a un ampio spettro di “altro da noi”. Il che può essere motivo di entusiasmo per alcuni, e di disorientamento, a tratti di terrore per altri. Il modo in cui reagiamo di fronte alle innumerevoli opportunità che il mondo ci mette a disposizione per incontrare l’altro rivela moltissimo su noi stessi e sul nostro sistema di valori. Soprattutto se con questo “altro” condividiamo una lunga storia di punti in comune, ma anche di inimicizia. Ignorarsi l’un l’altro è difficilmente praticabile. La scelta allora ha a che fare con il modo in cui usiamo gli strumenti di questo nostro mondo iper-connesso: per spargere sale sulle ferite, o per tentare di guarirle.
Mi incontro con Rima nel suo ufficio di Milano. Rima Sghaier è un’attivista, blogger e ricercatrice tunisina di 25 anni. Ha conseguito la laurea triennale in Diritto e Scienze Politiche presso l’Università di Tunisi e sta per ottenere la magistrale nello stesso ambito. Ha una storia di attivismo digitale cominciata al liceo, che le ha aperto una finestra sul mondo al di là della Chebba (la sua cittadina natale) e l’ha portata (almeno per ora) fino a Milano. Qui, lavora come Outreach Director press il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, una Ong che sviuppa tecnologie a supporto del whistleblowing (per i non addetti ai lavori: software che consentono la denuncia di episodi di corruzione all’interno del proprio ambiente in anonimato e sicurezza). Nel 2016, il Guardian l’ha inserita nella lista dei 10 leader africani emergenti per la trasformazione digitale del continente. Tra le sue molte attività, Rima si dedica con passione al dialogo interreligioso, e in particolare a quello tra musulmani ed ebrei: ha lavorato come volontaria nel team PR della Muslim Jewish Conference e oggi, con il ruolo di Senior Digital Media Strategist fa parte della squadra della Muslim Jewish Interfaith Coalition.
Muslim Jewish Conference, Muslim Jewish Interfaith Coalition. Con tutta probabilità, i nostri lettori sanno poco o nulla di queste iniziative. Di che cosa si occupano e come si differenziano l’una dall’altra?
“La Muslim Jewish Conference è una Ong con sede a Vienna, che ogni anno riunisce insieme musulmani ed ebrei che vogliono conoscersi, combattere la diffidenza e affrontare le sfide delle loro comunità. Ho partecipato per la prima volta nel 2014 e l’esperienza mi ha cambiato la vita. Come per le mie altre attività e passioni, il mio interesse per il dialogo interreligioso è iniziato su Internet, soprattutto con il movimento YaLa Young Leaders , di cui ho iniziato a far parte a 18 anni”. [YaLa Young Leaders è un movimento online, basato su Facebook, che tramite programmi di e-learning promuove la pace e la conoscenza reciproca tra i giovani di Medio Oriente e Nord Africa]. “La Muslim Jewish Conference è diversa da YaLa, lì non sei più su Internet: ti incontri faccia a faccia per la prima volta, però – questo è il bello – lo fai in uno spazio sicuro. Uno spazio sicuro ti consente di mettere sul tavolo della discussione tutte le questioni calde: è un privilegio che nella vita quotidiana ti puoi difficilmente permettere, perciò cerchi di trarne il meglio. Ogni edizione della MJC comincia sempre col separare i partecipanti nei rispettivi gruppi di affiliazione e condividere apertamente gli stereotipi radicati contro la controparte. Le attività che seguono sono ricche e diversificate, molto attente all’importanza di partire dal basso, di rivolgersi a persone che non hanno una formazione specifica sul dialogo interreligioso.
Inoltre, prima della MJC non avevo mai preso parte a qualcosa che davvero tocca il cuore delle questioni religiose, per me è stata una grande novità. Da allora, sono stata volontaria nel team PR per un altro forum della MJC, nel 2016 a Berlino. Oggi sono felice di essere parte di una nuova iniziativa nata dal basso: la Muslim Jewish Interfaith Coalition, il cui forum inaugurale è previsto per la fine di agosto a Essaouira, in Marocco”.
La scelta del luogo (una città araba, non europea) riflette una differenza di prospettiva tra le due iniziative?
“Il nostro staff proviene in gran parte da esperienze all’interno di organizzazioni locali e internazionali, e desidera far fruttare il proprio impegno aprendosi a target più ampi. I nostri sforzi sono complementari, nel senso che servono tutti lo stesso scopo: guarire la diffidenza tra due comunità. Oltre al dialogo e a esercizi di costruzione delle relazioni, il forum inaugurale della Muslim Jewish Interfaith Coalition offre strumenti organizzativi ai partecipanti con abilità professionali specifiche. Tutti i nostri eventi avranno un qualche momento di apprendimento basato sui testi e su elementi di teologia e non si concentreranno esclusivamente sulla connessione culturale. In ultima istanza però, ciò che ci distingue è la volontà di lavorare con due categorie particolari: gli ebrei ortodossi e i musulmani religiosi sono una, gli ebrei mizrahim e gli arabi musulmani sono l’altra. In futuro, la Coalition prevede di organizzare anche forum in Europa, ma per quel che riguarda il lancio, la scelta del luogo è certo molto simbolica. Ha a che fare con la storia intima della fondatrice, Rachel Delia Benaim.
Rachel è una giornalista e reporter statunitense, figlia di un ebreo marocchino. Sua nonna è cresciuta proprio a Essaouira, una città che un tempo aveva il 40% di popolazione ebraica e la cui eredità ebraica è ancora molto presente. Rachel ritiene che ebrei mizrahim e arabi musulmani siano una chiave per un lavoro di guarigione che musulmani ed ebrei devono operare a livello globale. Qui risiede dunque la specificità della Muslim Jewish Interfaith Coalition: il focus sul dialogo tra ebrei di discendenza mizrahi e arabi musulmani, che hanno così tanto in comune, ma sono anche divisi da narrative e percezioni diverse sulla Storia recente. Le comunità ebraiche sono sparite quasi o del tutto dal mondo arabo nel giro di un paio di decadi e noi vogliamo parlarne, saperne di più. Non riguarda solo il passato, è un terreno di prova per discutere come i nostri Paesi possano essere più inclusivi”.
Dai musulmani e dagli ebrei ci si aspetta che siano nemici, almeno in base a una narrazione stereotipata. Perché impegnarsi in queste attività? È solo per un gusto di ribellione, di trasgressione contro ciò che la società si aspetterebbe da te?
“Guarda, in genere, di critiche se ne ricevono in continuazione. Perché fai questo e non quello? Per esempio, io scrivo molto sulle violazioni dei diritti umani in Medio Oriente e Nord Africa. Scrivo qualcosa sull’Egitto? La gente ti chiede perché non parlo della Siria, e così via. A una certa devi smettere di dare importanza ad attacchi che non hanno nulla di costruttivo e concentrarti su ciò che per te conta davvero. Tornando al nostro argomento, conosco molte iniziative di dialogo interreligioso dallo spirito più “universale”, aperte a uno spettro più ampio di persone e credi. Ma per affrontare problemi specifici, devi “zoomare” e lavorare su soluzioni specifiche. E io ho scelto di “zoomare” sul dialogo giudeo-musulmano, perché è qualcosa che davvero manca.
È vero che da musulmani ed ebrei ci si aspetta che siano nemici; ed è vero che lo sono, a molti livelli. Questo tocca direttamente la quotidianità di molti, in numerosi Paesi. Perciò non stiamo parlando di ribellione verso la società perché “fa figo”: stiamo parlando di affrontare una realtà che fa paura. Nel mio Paese, la Tunisia, dare a qualcuno dell’ebreo corrisponde a un insulto; così è la parola “arabo” per molti ebrei. Voglio esplorare le radici di quest’odio, capire la provenienza di questa brutta immagine dell’altro. C’è un grande lavoro di guarigione da fare. Io per prima, cresciuta in un ambiente molto conservatore, ho dovuto ripensare tanti miei pregiudizi. È dura, ma noto che sempre più persone mostrano interesse. C’è un sacco da fare, tra organizzazione, recruiting e logistica, ma è incoraggiante ricevere adesioni da ogni tipo di comunità: poco importa quanto questa sia chiusa, dall’interno salta sempre fuori qualcuno desideroso di aprirsi. Il fattore umano di queste iniziative è straordinario, è il catalizzatore della guarigione”.
C’è qualche storia speciale che ti senti di condividere?
“Ce ne sono così tante! Scelgo quella di un caro amico, Mohammed Al Samawi. Mohammed è un giovane yemenita, che ha iniziato a occuparsi di dialogo interreligioso attraverso l’attivismo online. Allo scoppio della guerra civile, si è trovato in grave pericolo di vita, tra bombardamenti a tappeto sulla sua città e milizie di estremisti che circondavano la sua abitazione. Disperato, ha chiesto aiuto al suo network virtuale, a persone che nella vita reale non aveva mai incontrato. E il miracolo si è compiuto: quattro persone, di tre fedi diverse gli hanno risposto e, senza nessuna particolare competenza in diplomazia internazionale, sono riuscite a tirarlo fuori dallo Yemen. Mohammed oggi vive negli Stati Uniti e ha da poco raccontato la sua storia nel libro The Fox Hunt. Non voglio spoilerarlo più di così! Ma ci tenevo tanto a parlare della sua storia, perché risponde appieno alla tua domanda di prima sulle motivazioni del nostro impegno: è la prova che, a volte, lo sforzo di conoscere l’altro potrebbe salvare una vita.”
Torniamo alla Muslim Jewish Interfaith Coalition: come pensate di lavorare, con quali strategie?
“La sfida principale è riuscire a interessare un target “impegnativo”, vale a dire persone che non sono attivamente coinvolte nel dialogo interreligioso – e anzi, aggiungerei, che non lo vedono molto di buon occhio. Internet può offrire grandi possibilità. Io lavoro nel team di strategia digitale, insieme ad altre tre giovani donne, con le quali sono diventata amica grazie a precedenti iniziative di peace-building e dialogo. La nostra strategia si concentra sul mantenimento del dialogo anche dopo gli incontri dal vivo, attraverso la creazione di contenuti web e social che promuovano la collaborazione e la conoscenza reciproche e il contrasto all’incitamento all’odio con l’educazione digitale. Hai presente “People of the Book”? È un canale YouTube creato da Elhanan Miller, un giornalista e studente rabbinico che conosce l’arabo e realizza brevi video animati per spiegare l’ebraismo ai musulmani. Lui è uno dei nostri partner e la nostra intenzione è creare video simili, in arabo, ebraico e altre lingue, per contrastare ignoranza e luoghi comuni verso le tradizioni e il credo dell’altro.
Il lavoro online è complementare agli incontri dal vivo. Come dicevo, non vogliamo incontrarci una sola volta, bensì creare e mantenere una continuità. I nostri forum si rivolgeranno a diverse categorie. Ad esempio, questo inaugurale è pensato per giovani professionisti. Ma prevediamo di organizzarne uno per gli studenti, uno per i leader religiosi, uno per i leader politici…vogliamo esplorare e cercare di spezzare quel cerchio narrativo che in un gruppo genera ostilità verso l’altro. Inoltre, la Coalition avrà spazio anche per il dialogo intra-religioso, perché è fondamentale investigare la diversità esistente tra chi è parte di una stessa comunità.

Molti partecipanti a queste iniziative di dialogo interreligioso vivono in Occidente come minoranza. Devono relazionarsi a un “terzo altro”, che rappresenta la maggioranza e ha potere e influenza nella politica, nei media, nella società. Per dirne una, il recente studio “Essere cristiani in Europa occidentale del Pew Research Center mostra che circa un quarto di cristiani in Europa non accetterebbe un ebreo o musulmano come vicino di casa o membro della famiglia. La domanda è: come portate il vostro messaggio all’esterno?
“Il punto di partenza è creare contenuti contro l’incitamento all’odio. Con la Coalition, abbiamo in mente di farlo in diverse lingue europee. La parola chiave è “localizzazione”: creare contenuti locali, avere un network di organizzazioni dal basso; offrire training a giovani professionisti e gruppi che interagiscano con le istituzioni, che facciano pressione per leggi migliori e per creare spazi sicuri di dialogo interreligioso nei diversi Paesi; dimostrare che ogni situazione negativa può avere una risposta differente. Per esempio, la campagna d’odio “Punish a Muslim day” nel Regno Unito ha provocato così tante meravigliose contro-reazioni, da parte di tante persone che hanno fatto tutto il possibile perché i loro vicini musulmani si sentissero al sicuro”.
Com’è successo che una persona come te, nata in una cittadina nordafricana e, come hai detto prima, cresciuta in un ambiente conservatore, finisse a occuparsi di tutto questo?
“Francamente non saprei proprio, ho studiato sociologia quel che basta per sapere che non posso dare una spiegazione precisa alle mie scelte! Forse è stata la mia fame di conoscenza. La lettura e Internet hanno avuto un grande ruolo, cercavo in essi tutto ciò che non riuscivo a trovare nella piccola biblioteca della scuola. Poi d’improvviso, la Rivoluzione. Era il 2011 e io avevo 18 anni. Fino a quel giorno, ero stata indottrinata: Rima, tu non potrai mai cambiare niente. E invece, ecco che la coltre iniziava a dissolversi. A partire da quel momento, sono stata prima impegnata come admin e creatrice di contenuti della pagina Facebook “The Enlightened Minds”, creata da un attivista civile libanese (ora uno scienziato), Moustapha Itani. Lo scopo della pagina era provare insieme a criticare le nostre società, mettere in discussione i nostri pregiudizi. Da quell’esperienza ho deciso che avrei messo tutto l’impegno possibile per promuovere il cambiamento tramite le nuove tecnologie. Poi mi sono trasferita nella capitale, Tunisi, per frequentare l’università, e mi sono unita a un comitato giovanile legato alla sezione locale di Amnesty International, e successivamente ho aderito al progetto “Giovani leader di Tunisi” per la promozione della partecipazione dei giovani nella vita pubblica. La mia prima esperienza “interregionale” è stato il programma Mena Leaders for Change di YaLa Young Leaders: interessarmi alle iniziative di pace e dialogo interreligioso è stato giusto il passo successivo”.
Hai più volte fatto riferimento all’importanza di affrontare i temi religiosi. Che cos’ha questo a che vedere con la tua esperienza di vita personale?
“A partire dall’adolescenza ho iniziato ad accorgermi di come tante persone venissero escluse a causa del loro approccio non convenzionale alla religione. Nella mia comunità, ad esempio, è ancora molto problematico dichiararsi apertamente non religiosi o “diversamente musulmani”, mettere in discussione in modo oggettivo e costruttivo o cercare riformare ciò che da tutti è accettato, che siano leggi, regole o tradizioni. Chi lo fa ha vita dura. La religione è ancora percepita come una faccenda di eredità familiare che non si dovrebbe mettere in discussione. È un atteggiamento che genera ingiustizia e oppressione, e ha ripercussioni sulla vita pubblica e sulla difficoltà di mantenerla separata dalla religione, benché questo sia uno dei principi fondamentali della nostra nuova Costituzione. Ho imparato negli anni a elaborare la mia rabbia di fronte all’ingiustizia, a sforzarmi di capire perché gran parte della mia società ragiona in questo modo, e cosa posso fare per migliorare la situazione. Noi tunisini siamo “ufficialmente” sunniti malikiti, che è soltanto una delle molte scuole dell’Islam. Le iniziative di dialogo mi hanno aiutato non solo a conoscere altre religioni, ma anche a scoprire nuovi modi di percepire e praticare l’Islam. Ecco perché insisto così tanto sull’importanza del dialogo intra-religioso accanto a quello interreligioso.
Torniamo un attimo a quel che dicevi prima sull’obiettivo della Coalition di lavorare per guarire le ferite della Storia. Quando si parla dell’esodo ebraico dai Paesi musulmani, le parti sono tendenzialmente legate a una narrazione bianco/nera. “Avete messo in pericolo la nostra esistenza, ci avete cacciati”, dicono gli ebrei. “No, siete voi che avete voluto andare in Israele, nessuno vi ha obbligati”. Come si può passare oltre questa narrazione duale?
“È proprio ciò che vogliamo affrontare. Ci sono state vicende diverse a seconda dei Paesi, delle famiglie, delle situazioni. Vogliamo che le persone condividano e discutano le loro storie, non vogliamo arrivare a un’unica risposta. Perché, lo ripeto ancora una volta, non si tratta di assistere a una lezione di storia. Vogliamo esplorare il passato per capire il presente, per capire l’assurdo delle nostre società: che cos’è successo? Com’è stato che abbiamo fatto questa fine? Vogliamo restaurare ciò che può essere restaurato”.
Su un ultimo punto vorrei avere la tua prospettiva. Da una parte, come abbiamo appena detto, c’è questa narrazione duale. Dall’altra, la partenza degli ebrei dai Paesi musulmani ha lasciato dietro di sé una grande nostalgia. La ritrovi nell’opera degli artisti ebrei mizrahim, che sospirano per il Mediterraneo aperto, cosmopolita dei tempi d’oro. La ritrovi nei racconti degli anziani, in come alcuni aspetti del lascito ebraico (come i grandi cantanti) siano ancora così popolari tra i musulmani. Tu non hai vissuto questa storia, ma sei nata in una società che ne è il prodotto. Nel tuo impegno per riconciliare musulmani ed ebrei non c’è anche la ricerca di una parte di te stessa?
“Ci ricolleghiamo a quanto dicevo prima sullo sforzo di rendere le nostre società più inclusive, più consapevoli che l’eredità culturale è il prodotto di molti diversi contributi. Per esempio, se mi chiedi della Tunisia, non c’è dubbio che il patrimonio ebraico sia parte di me e della nostra cultura nazionale. Hai citato i cantanti, e difatti ci sono stati questi artisti prominenti che hanno creato nuove scuole di musica e sono tuttora così famosi e amati. Ma non penso a loro come a “musicisti ebrei tunisini”, per me sono semplicemente tunisini. All’epoca a nessuno importava, erano artisti di talento a cui era capitato di nascere ebrei. Dobbiamo preservare questa memoria, ma non solo dal punto di vista nostalgico del “Ya Hasra”, se mai prendendo coscienza che scavare nel nostro passato ci permette di scoprire più su noi stessi, di andare al di là dei tabù e di trovare intersezioni nelle quali possiamo identificarci l’uno nella storia dell’altro”.
Siamo nel 2011, pochi mesi dopo lo scoppio della Rivoluzione Tunisina: una regista francese di origini tunisine, Sarah Benillouche, gira per Tunisi per scoprire cosa sia rimasto della memoria di Habiba Messika (1903-1930), la celebre cantante e attrice ebrea tunisina che fu un mito per la sua generazione e per quelle successive. Il risultato è “Ciao Habiba!”, un “documentario impressionista”, come lo definisce la regista, con attori professionisti e non che entrano in scena a condividere i loro ricordi e pensieri. Dopo la mia conversazione con Rima, il monologo di Annie Fitoussi, che recita sul finire del film, mi risuona nella testa:
“Tutti ne fanno lo stesso ritratto. Habiba non amava i gruppi chiusi, non era una settaria, faceva l’amore con tutti, ebrei e arabi. Habiba non viveva nel ghetto. Che volete che vi dica su di lei? Che a lei tutto questo non piacerebbe. A lei piacerebbero i balli, I canti, le piacerebbero…gli indignati! […]. Ma non la nostalgia, non le ripetizioni, non questo continuo “E com’era bella la Tunisia, e io sono nato nella tal via, e mio padre faceva questo, e mio nonno faceva quell’altro, e ci vedevamo, e mangiavamo le noccioline”…ma basta, smettetela! Tutto ciò è finito, quel mondo non esiste più. Non siamo più là. Siamo qui”.
Noi siamo qui.